CODEX ATLANTICUS, 11
 New York, 19 ottobre 2008
New York, 19 ottobre 2008
Una recensione sul New York Times di ieri comincia citando un aforisma di William Faulkner: “Il passato non muore mai. Anzi, non è nemmeno passato”. È una frase apocrifa? E se no, qual è il suo contesto? Ma per il momento ciò non importa, e mi permetto un’estrapolazione (che ogni aforisma peraltro incoraggia). A me leggendo questa frase è venuto in mente (con una associazione zig-zagante di idee) come qualche tempo fa uno dei più discutibili protagonisti della sciagurata politica americana in Iraq, Donald Rumsfeld, usasse riferirsi con sprezzante ironia alla “Old Europe”. Allora trovavo irritante questo epiteto; ma adesso vorrei rovesciarlo in una sorta di piccolo aforisma, o aforismetto, personale:
– Ebbene sì: l’Europa sarà sempre vecchia, anche se le sue innovazioni sono reali, e la sua gioventù è brillante; e d’altra parte gli Stati Uniti saranno sempre nuovi, per quanto efficace sia la coltivazione della loro storia e tradizioni.
Ciò non è né un bene né un male: più passa il tempo, più nettamente ciascuno dei due continenti è confermato nella sua essenza; è condannato – o promosso – a essere se stesso. La saggezza storica (se una tal cosa esiste) consiste forse nell’accettare la fondamentale datità della storia – ovvero della retorica. Tutte le grandi retoriche sono divenute realtà, e determinano il comportamento di società intere.
 North Branford (Connecticut), 4 novembre 2008
North Branford (Connecticut), 4 novembre 2008
Oggi ho votato per le elezioni presidenziali (è la mia terza o quarta votazione per eleggere il presidente, e ogni volta ne sento l’eccitazione e il privilegio). Quando entro con l’automobile nel vialetto della scuola elementare “Jerome Harrison” lungo l’Autostrada Ottanta fra North Branford e New Haven (la seconda di queste cittadine è sede dell’università di Yale, alla cui biblioteca mi sto recando dopo il voto), alle ore 7 e 10 del mattino è già molto difficile parcheggiare: la grande affluenza mi sembra puntare verso la vittoria di Obama. (Sto scrivendo questi appunti alle nove di mattina, non dispongo di televisione o di radio, dunque non ho ancora – né avrò per la maggior parte della giornata – informazioni attendibili sull’andamento delle elezioni.)
Ho votato per Obama, naturalmente; ma questo “naturalmente” è un avverbio rassegnato e autoironico. Mi sono lasciato alle spalle la politica come passione, anche se continuo a seguire la vita politica su entrambe le sponde dell’Atlantico; anzi, la seguo più attentamente che mai. La politica continua a occupare buona parte delle mie energie intellettuali perché essa è il modo più vivido in cui si manifesta la fenomenologia del mondo, e perché continua a riportare alla mente in modo particolarmente acuto il paradosso dell’amicizia. Quanto alla fenomenologia del mondo, essa va assunta in tutta la sua vastità, che può portare a una visione mistica della politica (un altro paradosso, apparentemente – ma penso, per esempio, al Bhagavad Gita). Per ciò che riguarda il paradosso dell’amicizia, provo a spiegarmi con un episodio di molti anni or sono, quando ancora frequentavo le sessioni religiose domenicali dei Quaccheri – le loro suggestive sedute silenziarie.
In uno dei brevi interventi meditativi che punteggiano l’ora silenziaria in questa liturgia molto laica della Società degli Amici (i Quaccheri, appunto), una donna a un certo punto si alzò ed esclamò: “Friends do not let friends vote Republican”. Costei stava parodiando uno slogan molto diffuso nelle campagne per la sicurezza stradale; “Friends do not let friends drive while drunk” (ovvero: ‘Un vero amico non lascia che i suoi amici guidino in stato di ubriachezza’). Tale parodia non era un’invenzione di quella signora: già allora circolava, e ha continuato a circolare – tanto è vero che alcuni giorni or sono l’ho letta sul paraurti posteriore della macchina in fila davanti a me (lo slogan parodistico era stato rispolverato in questi ultimi giorni febbrili prima delle elezioni): ‘Un vero amico non lascia che i suoi amici votino repubblicano’ – cioè, una certa scelta politica viene paragonata a uno stato pericoloso di alterazione della coscienza, per cui chi vi propende deve essere protetto da se stesso.
Ricordo ancora – da quella funzione quacchera di una mezza dozzina d’anni or sono – il senso di sorda e al tempo stesso acuta irritazione che allora mi colse. Quella battuta segnava una rozza irruzione del politico dentro lo spirituale. E sentii una volta di più, in contrasto, la saggezza e l’eleganza dello stile cattolico (tanto spesso, e tanto ingiustamente, tacciato di ipocrisia): lo stile che evita di esplicitare le prese di posizione ideologiche in modo così crudo e diretto (la crudezza e la unidirezionalità essendo tipiche del piccolo cabotaggio politico).
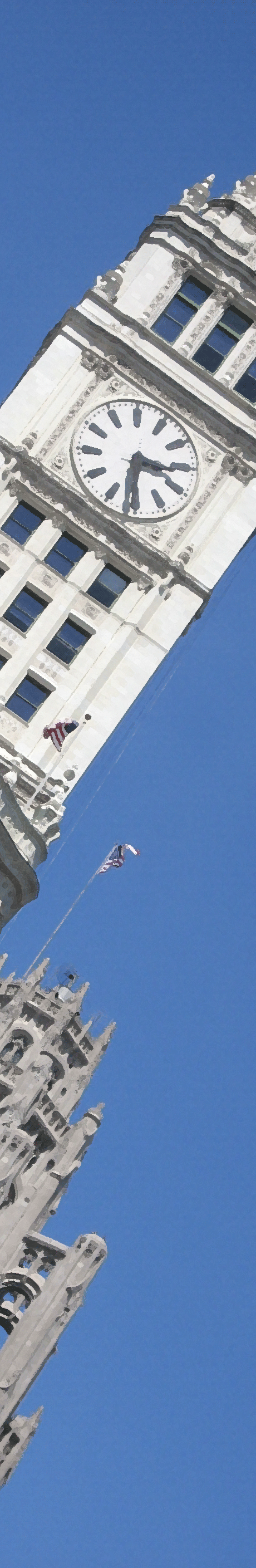 Quel che volevo arrivare a dire (lungo il filo avvolto e riavvolto del mio pensiero itinerante) è che la battuta di quella signora rappresentava il modo sbagliato di vivere il rapporto tra amicizia e politica: mostrava il desiderio di irregimentare politicamente i propri amici. Io invece sono dispiaciuto di non conoscere direttamente nessuno che oggi abbia votato repubblicano. Questa è una lacuna grave, un segno che sono finito dentro un mondo troppo ristretto; dunque è tutt’altro che un segno positivo; l’ingabbiatura ideologico-sociale non è mai un buon segno. E il fatto invece che tutti i miei amici di sinistra (vale a dire, quasi tutti i miei amici in Italia) considerino questo ingabbiamento come un’insegna o stemma di coerenza che essi ferreamente desiderino – questo è uno dei tanti fenomeni che marcano l’arretratezza della vita civile o civica in Italia; altro che “società civile”!
Quel che volevo arrivare a dire (lungo il filo avvolto e riavvolto del mio pensiero itinerante) è che la battuta di quella signora rappresentava il modo sbagliato di vivere il rapporto tra amicizia e politica: mostrava il desiderio di irregimentare politicamente i propri amici. Io invece sono dispiaciuto di non conoscere direttamente nessuno che oggi abbia votato repubblicano. Questa è una lacuna grave, un segno che sono finito dentro un mondo troppo ristretto; dunque è tutt’altro che un segno positivo; l’ingabbiatura ideologico-sociale non è mai un buon segno. E il fatto invece che tutti i miei amici di sinistra (vale a dire, quasi tutti i miei amici in Italia) considerino questo ingabbiamento come un’insegna o stemma di coerenza che essi ferreamente desiderino – questo è uno dei tanti fenomeni che marcano l’arretratezza della vita civile o civica in Italia; altro che “società civile”!
Tornando al mio voto per Obama, penso a quello che spesso chiamo tra me “il teorema di Chomsky”: un “teorema” peraltro non troppo originale (è in fondo una tarda eco delle riflessioni di Machiavelli), che io associo a Chomsky perché lo ascoltai enunziato in modo particolarmente chiaro da lui – con il suo fascino della quietezza – in un’intervista che gli feci nei tardi anni Settanta. Ecco in parole povere il “teorema”: un neo-eletto presidente repubblicano deve rassicurare la popolazione, preoccupata dalla tradizionale sordità o miopia (metafora a scelta) dei Repubblicani sulle politiche sociali – dunque tenterà di andar oltre i limiti del suo partito, di essere più espansivo nei suoi piani sociali; d’altra parte, sapendo che il pubblico è rassicurato dalla tradizionale durezza repubblicana in politica estera, potrà permettersi di prendere alcune iniziative distensive in questo campo. È chiaro, a questo punto, quale sarà la seconda parte del “teorema”: un presidente democratico appena eletto potrà contare sul tradizionale patrimonio di buona volontà accumulato dal suo partito nella politica sociale, dunque potrà permettersi di stringere i cordoni della borsa; d’altra parte dovrà rassicurare il pubblico sulla “morbidezza” di cui i Democratici sono spesso accusati, dunque sarà particolarmente tentato di concedersi il lusso di qualche avventura guerresca. Ecco perché ho votato Obama “naturalmente” – cioè rassegnatamente, cioè senza troppe illusioni.
Con tutto ciò (e augurandomi comunque che il “teorema chomskyano” venga smentito), non ho mai pensato nemmeno per un momento di votare il candidato repubblicano. Oltre tutto, ricordo bene quanto una persona cara che ora non è più tra noi fosse decisa nel sostenere Obama, e spesso questo tema emergeva nelle nostre brevi ma semi-quotidiane conversazioni telefoniche fra Stati Uniti e Italia. Ecco, è riapparso quello che ho chiamato il paradosso dell’amicizia: credo che l’affettuosità dell’amicizia debba, se necessario, tagliare attraverso i confini della politica vista (tradizionalmente e riduttivamente) in termini di razionalismo, o meglio intellettualismo, ideologico; e così, il voto elettorale può anche essere l’espressione di un lascito di amicizia.
Greenwich (Connecticut), 4 gennaio 2009
È vero – è vero, il luogo comune sulla profonda o sfondata banalità dela televisione. Ho passato due serate (Capodanno, e il 2 gennaio) a guardare la TV, e ciò mi ha fatto passare ogni possibile nostalgia a questo proposito. (È da qualche anno che ho rinunziato alla televisione, e il mio unico rimpianto è non averlo fatto prima.)
La diabolica (non mi pare un termine eccessivo) efficacia contagiante della televisione si manifesta anche nel suo essere riuscita a neutralizzare la sua critica, trasformandola in cliché: tutti guardano dall’alto in basso (superciliosamente) alla televisione, ma pochi riescono a non guardarla. E questa è una metonimia della condizione contemporanea: enunziare una tesi più o meno “progressista” sull’umana società per autorizzarsi a vivere il comportamento opposto. E allora: parlare della “crisi del mondo moderno” vuol dire ‘sguazziamoci dentro’; parlare del “problema ecologico” significa ‘glug, slurp, glug-glug’; dire “stasera alla televisione non c’è niente da vedere” (come diceva sempre la mia povera mamma) vuol dire che ci si sta legittimando a guardarla; ecc.
La linea genealogica è chiarissima, e sta sotto gli occhi di tutti: la TV è la bastardizzazione del cinema, che a sua volta è l’imbastardimento del teatro. La TV è una droga di tipo sedativo; è un’iniezione di vaccino depressivo per tentare di combattere la depressione – ma questa vaccinazione può avere un effetto boomerang.
 Poscritto sul cinema. Non è completamente esatto dire che il cinema è l’imbastardimento del teatro. Il cinema è l’imbastardimento del teatro, e della fotografia, e della narrativa. (Adorno definisce da qualche parte il cinema come una mésalliance della fotografia e del romanzo.) Insomma il cinema è un monstrum – nel senso antico, che non è completamente negativo: è un ibrido affascinantemente pauroso, che prelude a tutte le ammucchiate mediatiche post-cinematografiche.
Poscritto sul cinema. Non è completamente esatto dire che il cinema è l’imbastardimento del teatro. Il cinema è l’imbastardimento del teatro, e della fotografia, e della narrativa. (Adorno definisce da qualche parte il cinema come una mésalliance della fotografia e del romanzo.) Insomma il cinema è un monstrum – nel senso antico, che non è completamente negativo: è un ibrido affascinantemente pauroso, che prelude a tutte le ammucchiate mediatiche post-cinematografiche.
Treno Roma-Bologna, 18 febbraio 2009
Partendo dalla frase narrativo-aforistica di Pavese: “Ogni guerra è una guerra civile”, scrissi (prima in prosa, poi in una poesia) un mio proprio aforisma: “Ogni vittoria è una vittoria di Pirro”. Quest’ultimo aforisma richiede ora di essere sviluppato.
I paesi sconfitti iniziano molto rapidamente la rielaborazione e sublimazione della loro sconfitta (penso soprattutto allo sviluppo economico- industriale); essi compensano questa sconfitta con un intenso lavorio sociale – e l’Italia ne è un ottimo esempio, non troppo distante dalla Germania e dal Giappone. I paesi vincitori invece scontano (compensano, risarciscono) la loro vittoria con ritmi più lenti, con sviluppi sotterranei, e si capisce: la hybris della vittoria – con la sua connessa illusione che non vi sia nulla da scontare, nulla da veramente pagare, a parte qualche risarcimento economico – è un’ubriacatura che dura molto a lungo; la natura pirrica della vittoria non ha fretta di rivelarsi. E si capisce allora anche come il più forte, e conseguentemente il più arrogante, dei vincitori (gli Stati Uniti) ci abbia messo più degli altri a pagare. In effetti, gli Stati Uniti hanno cominciato da relativamente poco tempo a pagare, e ancora non hanno ammesso che è proprio questo ciò che gli sta succedendo.
In questo senso l’Italia – se solo gli Stati Uniti riuscissero a prenderla sul serio – potrebbe offrire alcune utili lezioni, per cominciare ad abituarsi alle nuove realtà. Ma l’Italia è piccola, è poco importante sullo scacchiere mondiale; inoltre l’Italia è eccessivamente autocritica, mentre gli Stati Uniti all’opposto sono quasi completamente sordi all’autocritica – sono (come dicevo) ancora accecati dalla hybris del loro preteso eccezionalismo. Questa teoria americana dell’eccezionalismo non è soltanto un fattore di accecamento, ma si configura come qualche cosa di simile a una bestemmia: contro il destino, se si vuole, o contro Dio, se si preferisce. (Questa bestemmia sciovinistica non è l’ultimo dei paradossi, in un paese che fortemente asserisce la propria religiosità.)
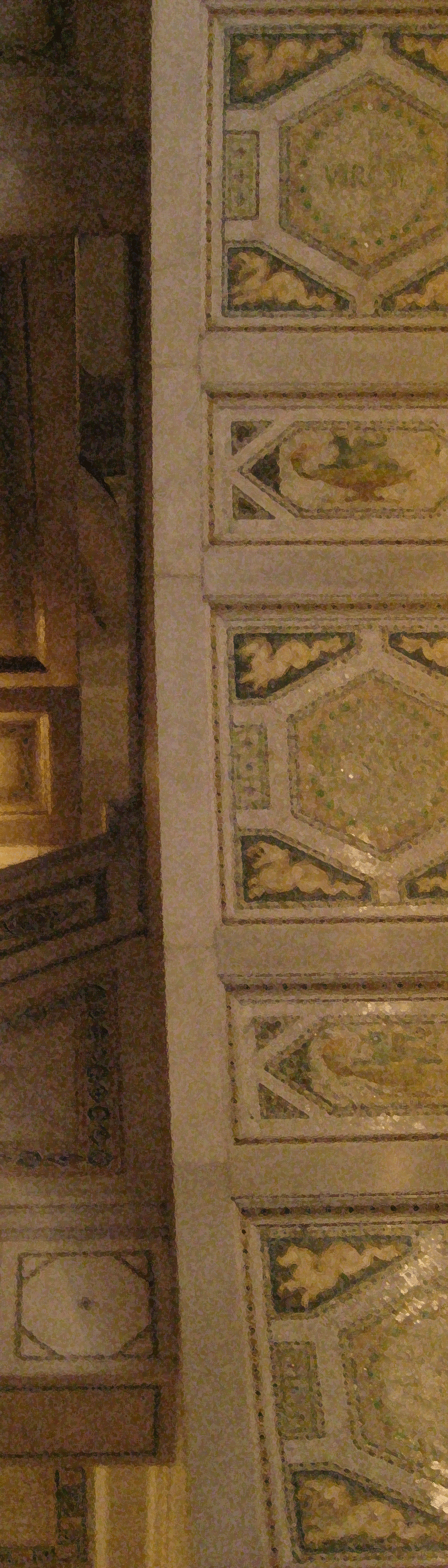 Tornando alla lezione italiana: nessuno, dentro e fuori dal paese, crede che l’Italia avrà mai più il ruolo di grande potenza al quale aveva per un certo tempo – nel primo anteguerra, e poi nell’intra-guerre – plausibilmente ambito. D’altra parte, il trauma della sconfitta italiana resta, e resterà per un tempo indefinito. Questo, perché l’Italia – a differenza della Germania e del Giappone – non si è mai misurata totalmente con la sua sconfitta: è sgattaiolata fuori dal conflitto, con un ravvedimento opportunistico che non poteva non apparire come un tradimento (un tradimento sornione e tardivo – lo si potrebbe chiamare un “tardimento”); e poi è riuscita con disinvoltura (la cui altra faccia peraltro è la goffaggine) a trasformare questo sgattaiolamento in vittoria, travestendo una guerra civile in “guerra di liberazione”. (D’altra parte non si possono ignorare i rapporti crudamente provvidenziali fra la grande storia e le storie piccole: quanti della mia generazione, me compreso, debbono la vita a questa goffa disinvoltura che ha ridotto il numero, comunque alto e grave, delle vittime civili della guerra civile in Italia?).
Tornando alla lezione italiana: nessuno, dentro e fuori dal paese, crede che l’Italia avrà mai più il ruolo di grande potenza al quale aveva per un certo tempo – nel primo anteguerra, e poi nell’intra-guerre – plausibilmente ambito. D’altra parte, il trauma della sconfitta italiana resta, e resterà per un tempo indefinito. Questo, perché l’Italia – a differenza della Germania e del Giappone – non si è mai misurata totalmente con la sua sconfitta: è sgattaiolata fuori dal conflitto, con un ravvedimento opportunistico che non poteva non apparire come un tradimento (un tradimento sornione e tardivo – lo si potrebbe chiamare un “tardimento”); e poi è riuscita con disinvoltura (la cui altra faccia peraltro è la goffaggine) a trasformare questo sgattaiolamento in vittoria, travestendo una guerra civile in “guerra di liberazione”. (D’altra parte non si possono ignorare i rapporti crudamente provvidenziali fra la grande storia e le storie piccole: quanti della mia generazione, me compreso, debbono la vita a questa goffa disinvoltura che ha ridotto il numero, comunque alto e grave, delle vittime civili della guerra civile in Italia?).
L’Italia dunque resta traumatizzata; ma in compenso le sue illusioni non fanno male a nessuno, al di fuori di lei. Gli Stati Uniti per contro hanno fatto scontare, e continuano a far scontare, le loro illusioni a tutto il resto del mondo. Fanno pagare insomma la loro “Grande Illusione”: che, cioè, il loro impero sia ancora saldo. L’esorcismo statunitense (ingenuo ed insieme efficace, come lo sono di solito gli esorcismi) consiste nel tentare di scampare alla decadenza che attende il loro impero – come ogni altro impero sotto il sole e la luna – evitando di chiamare se stessi “impero”.
Circola ancora un vecchio luogo comune, secondo il quale la storia dell’Impero Americano è parallela alla storia dell’Impero Romano; ora, i luoghi comuni – di cui spesso tentiamo di liberarci sogghignando – si rivelano spesso terribilmente plausibili. Non è facile stabilire quando siano cominciati il Declino e Caduta dell’Impero Americano – ma non è facile stabilirli nemmeno per l’Impero Romano; e del resto, la difficoltà o impossibilità di fissare cronachisticamente una data esatta non diminuisce la tragica esattezza della parabola generale. Ma non è poi necessaria una grande immaginazione storica per vedere nella guerra del Vietnam l’inizio della decadenza dell’Impero.
C’era una volta una coppia di giovani sposi – nel povero appartamento bohémien di un povero paesino del Massachusetts, Somerville, vicinissimo alla Cambridge ingioiellata dall’Università di Harvard – che ascoltavano alla radio nell’agosto del 1964 la versione di McNamara (il cui tono di voce dimostrava che egli mentiva sapendo di mentire) a proposito dell’ “attacco” nel Golfo del Tonchino che fornì il pretesto per il decisivo salto di “qualità” (o escalation) dell’intervento americano in Vietnam. Il brivido profondo che percorse quella coppia non nasceva soltanto dalla comprensione che era cominciata una vera e propria guerra (cosa non difficile da capire); era un brivido che veniva da più lontano – veniva dalla sconfitta italiana del 1945 – e più lontano andava: essi avevano intuito (intuizione non impossibile per una coppia europea ma pressoché impossibile, allora, per una coppia americana) che il Sogno Americano stava già avviandosi alla fine; proprio quando per loro, espatriati di fresco, era appena cominciato.
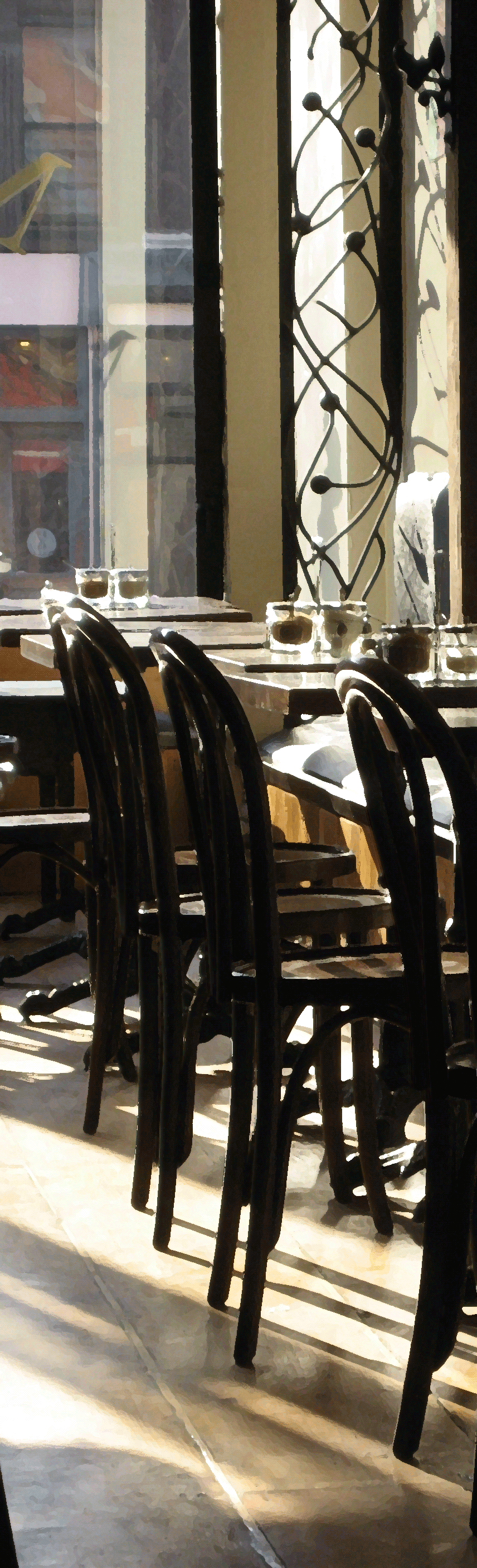 “La Grande Illusione”, “La Caduta dell’Impero Romano”, “Il Sogno Americano” … tutti titoli mediatici, come insegne luminose ... e, tutti, clichés terribilmente veri.
“La Grande Illusione”, “La Caduta dell’Impero Romano”, “Il Sogno Americano” … tutti titoli mediatici, come insegne luminose ... e, tutti, clichés terribilmente veri.
Greenwich (Connecticut), 28 febbraio 2009
Una coppia in automobile: lei che abita a Greenwich lo accompagna alla stazioncina dove lui prenderà il treno suburbano per Manhattan. Sono appena usciti da un piccolo bar chic e semideserto, dove hanno conversato di fronte a un bicchiere di vino insieme con altri due amici, dopo essere stati tutti insieme a una rappresentazione liceale. Un bar chic e semideserto?! Per chi abita a New York sarebbe un dettaglio inventato – un particolare romanzesco creato per gusto di ossimoro. (I bar, almeno a Manhattan, sono inesorabilmente affollati.) Ma qui siamo a Greenwich nel Connecticut: che è a un’oretta di treno da New York ma è già un mondo completamente diverso; un mondo che (a proposito di romanzi) forse sta aspettando un altro John-scrittore (John Cheever o John Updike) che rinnovi le saghe dei paesini della Nuova Inghilterra gravitanti verso New York o verso Boston. È un mondo di angoli boschivi, un mondo che ha delegato l’ostentazione alla città di New York, mentre qui vigono l’eleganza discreta e la tesaurizzazione invisibile. Insomma, Manhattan è prevalentemente la città dei prodighi – e inoltre dei poveri; mentre Greenwich, Guilford ecc. sono soprattutto le cittadine dei ricchi – e anche di borghesi più piccoli e più preoccupati. Il nesso tragico (chiaramente emerso in questi anni) fra potere economico e follia, a Manhattan diventa quasi orgiastico; a Greenwich e simili luoghi diviene invece qualcosa come un segreto, fra il sensuale e l’infamante. E così, gli avari/avidi di Greenwich risorgeranno “col pugno chiuso”, e i prodighi di Manhattan “coi crin mozzi” (Inferno VII 57).
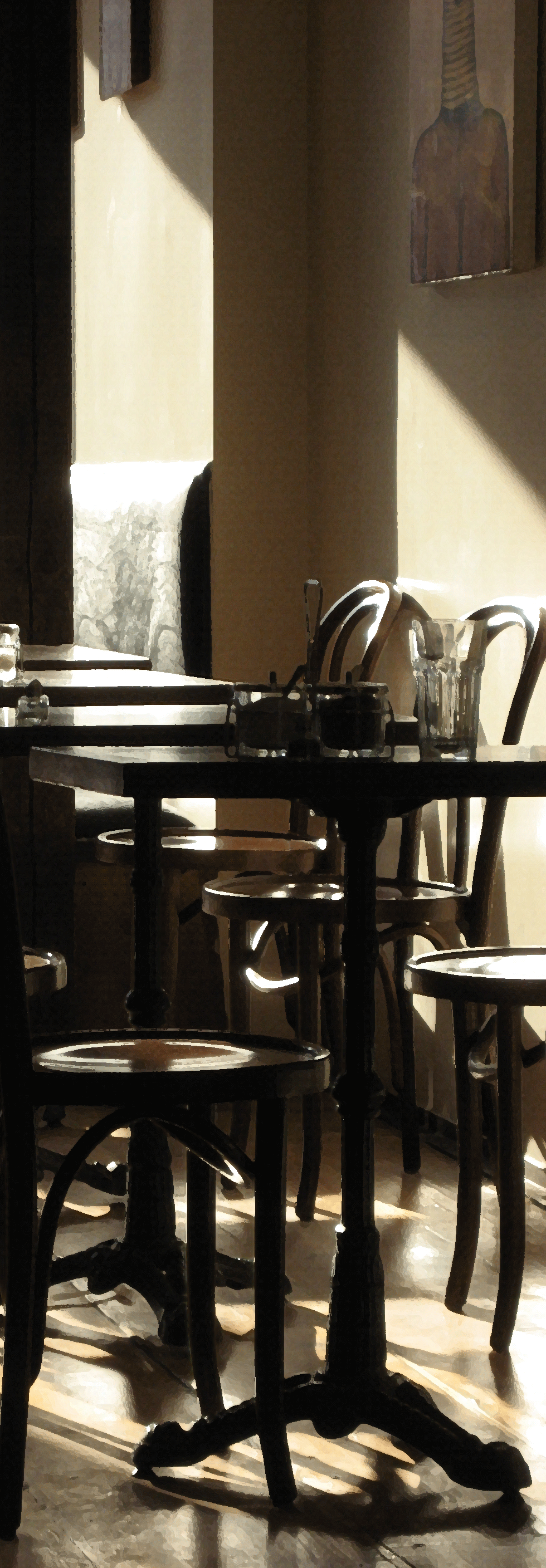 Quest’uomo qui, intanto, è doppiamente spaesato: in quanto manhattanita e in quanto persona che, a Manhattan (questa grande autorizzatrice di solitudini), riesce a fare una vita ritirata. Ha scoperto recentemente la parola recollectedness come sinonimo più rutilante di ‘raccoglimento’ – le parole lo aiutano a respirare meglio – e raramente lo si trova in giro, come oggi, dopo la mezzanotte. Ed è anche raro che si trovi, così tardi, a tentare un prolungamento di conversazione invece di appisolarsi (lui è un po’ orso, insomma). Ma qui e adesso, almeno un abbozzo di conversazione è difficilmente evitabile: per arrivare alla stazione è necessario un viaggetto di vari minuti, in un terreno boscoso, esteso ed irregolare (l’inglese dice sprawling – come dire: un paesaggio a gambe larghe). Le ricche case di Greenwich sono nascoste discretamente fra boschi e boschetti; e di notte bisogna stare attenti (dunque il viaggetto è un po’ più lento dei solito) ai cervi che possono distrattamente irrompere all’improvviso attraverso la strada, a volte sfondando con il loro brutale impatto parte dell’automobile insieme con parte del guidatore.
Quest’uomo qui, intanto, è doppiamente spaesato: in quanto manhattanita e in quanto persona che, a Manhattan (questa grande autorizzatrice di solitudini), riesce a fare una vita ritirata. Ha scoperto recentemente la parola recollectedness come sinonimo più rutilante di ‘raccoglimento’ – le parole lo aiutano a respirare meglio – e raramente lo si trova in giro, come oggi, dopo la mezzanotte. Ed è anche raro che si trovi, così tardi, a tentare un prolungamento di conversazione invece di appisolarsi (lui è un po’ orso, insomma). Ma qui e adesso, almeno un abbozzo di conversazione è difficilmente evitabile: per arrivare alla stazione è necessario un viaggetto di vari minuti, in un terreno boscoso, esteso ed irregolare (l’inglese dice sprawling – come dire: un paesaggio a gambe larghe). Le ricche case di Greenwich sono nascoste discretamente fra boschi e boschetti; e di notte bisogna stare attenti (dunque il viaggetto è un po’ più lento dei solito) ai cervi che possono distrattamente irrompere all’improvviso attraverso la strada, a volte sfondando con il loro brutale impatto parte dell’automobile insieme con parte del guidatore.
 Della rappresentazione teatrale (un gradevole quasi-musical dall’esile trama che consisteva essenzialmente in un pastiche di canzoni inglesi degli anni Venti, bene eseguite dalle fanciulle fiorenti in quell’elegante collegio privato) hanno già parlato al bar. E adesso, che dire? Ecco che, per rompere il silenzio nell’abitacolo circondato dalla notte, all’uomo viene una pessima idea: dire la verità – nel senso peraltro assai modesto (non è certo una questione di “Quid est veritas?”) di dire esattamente, fedelmente, una cosa che gli era venuta in mente al bar; e che allora (di fronte agli altri due che aveva appena conosciuto) non gli era sembrato il caso di piazzare sul tavolino – ma che adesso, con una vecchia amica e in una situazione più rilassata sente (probabilmente sbagliandosi) di potere azzardare; anche perché, dopo il calice di vino – uno solo, comunque – si sente un po’ più espansivo. Insomma, rispondendo a un’innocua domanda dell’amica:
Della rappresentazione teatrale (un gradevole quasi-musical dall’esile trama che consisteva essenzialmente in un pastiche di canzoni inglesi degli anni Venti, bene eseguite dalle fanciulle fiorenti in quell’elegante collegio privato) hanno già parlato al bar. E adesso, che dire? Ecco che, per rompere il silenzio nell’abitacolo circondato dalla notte, all’uomo viene una pessima idea: dire la verità – nel senso peraltro assai modesto (non è certo una questione di “Quid est veritas?”) di dire esattamente, fedelmente, una cosa che gli era venuta in mente al bar; e che allora (di fronte agli altri due che aveva appena conosciuto) non gli era sembrato il caso di piazzare sul tavolino – ma che adesso, con una vecchia amica e in una situazione più rilassata sente (probabilmente sbagliandosi) di potere azzardare; anche perché, dopo il calice di vino – uno solo, comunque – si sente un po’ più espansivo. Insomma, rispondendo a un’innocua domanda dell’amica:
LEI. – Allora, che te ne pare degli amici di stasera?
quest’orso di Manhattan abbozza niente po’ po’ di meno che una (brevissima, grazie al cielo) teoria del linguaggio:
LUI. – Beh, mi sono sembrati simpatici … e poi, Kathy è carina … ma debbo anche dire che mi sono trovato di fronte al solito problema …
LEI. – Cioè?
LUI. – Cioè: che la comunicazione fra esseri umani è sostanzialmente impossibile.
LEI. – Ma come sei esageraaato!
LUI. – No, vedi, è proprio così: e tu, esagerando come hai fatto la pronunzia della parola “esagerato” …
LEI. – E adesso che c’entra criticare la mia pronuncia?
LUI. – Ma non la criticavo affatto: volevo dire che, enunziando esageratamente la parola “esagerato” (tu infatti hai detto “esageraaato!”), hai messo in luce il fatto che io ho usato un’iperbole.
LEI. – Ecco la tua discriminazione: tu fai le iperboli (cosa che suona complicata ed elegante), mentre io faccio semplicemente delle esagerazioni …
LUI. – Scusa, ma non capisco perché tu continui a vedere una polemica là dove non ce n’era la minima intenzione – in effetti ti stavo dando ragione.
LEI. – Allora, ‘sta iperbole …
LUI. – L’iperbole è un’esagerazione dell’esagerazione, o se preferisci un’esagerata esagerazione.
 LEI. – Cioè, è meglio o peggio?
LEI. – Cioè, è meglio o peggio?
LUI. – Non è né meglio né peggio. Semplicemente, l’esagerazione è uno scarto nel discorso, che uno può lasciare così com’è, oppure tornarci sopra più tardi per rimetterla fra le righe. L’iperbole invece è un’esagerazione voluta, calcolata a scopo sperimentale.
LEI. – E quale sarebbe l’esperimento?
LUI. – Spingere un’idea al limite, e magari oltre, per vedere poi se funziona oppure no. Insomma, l’esperimento di cui parlo si attua attraverso la conversazione – è la conversazione come esperimento, che …
LEI. – Ho capito, ho già capito dove stai arrivando – alla tua evocazione favorita delle Grandi Epoche nella storia della conversazione: il Rinascimento italiano, il Settecento francese, tutti trionfi dell’arte della conversazione –
LUI. – Scusa, ma io non parlo di “arte della conversazione” che mi sembra un’espressione un po’ pigra. La vera conversazione è un esperimento cognitivo rischioso, e può essere rivoluzionante.
LEI. – Vabbè, comunque. Allora non credi veramente a quello che hai detto – che la comunicazione fra esseri umani sia sostanzialmente impossibile?
 LUI. – Io credo, che sia sostanzialmente impossibile – è un’ipotesi che non asserisco come certezza. Vedi, a me pare a volte che la lingua esista soprattutto per fraintendersi.
LUI. – Io credo, che sia sostanzialmente impossibile – è un’ipotesi che non asserisco come certezza. Vedi, a me pare a volte che la lingua esista soprattutto per fraintendersi.
LEI. – Un bel disastro, no?
LUI. – Ma no: in questo fraintendimento, c’è qualche cosa di vertiginoso e di bello.
LEI. – Appunto, dicevo: un bel disastro.
LUI. – E perché, disastro? Accettiamo il fraintendimento, piuttosto: tuffiamoci, sguazziamoci dentro. Accogliere in partenza il fraintendimento in tutta la sua ampiezza è il modo migliore di evitare illusioni; e a forza di fraintendersi, qualche volta si può arrivare a capirsi. È la nostra speranza – utopica necessaria realistica – di esseri umani che parlano.
LEI. – Beh, tu credi, come dicevi prima, che la comunicazione sia sostanzialmente impossibile. Con quest’avverbio, ti sei coperto le spalle, ammettendo che dentro certi limiti la comunicazione sia possibile. Infatti noi due stiamo parlando l’uno all’altra e sostanzialmente ci capiamo.
Intanto sono arrivati alla stazioncina, l’automobile si è allontanata tra i boschi agiati – e a volte meno-che-agiati: ci stanno dentro vari spazi di piccola borghesia che fatica. Lui resta a camminare su e giù lungo la piattaforma elevata da dove si vede nella strada in basso la vetrina illuminata di una boutique di auto di lusso.
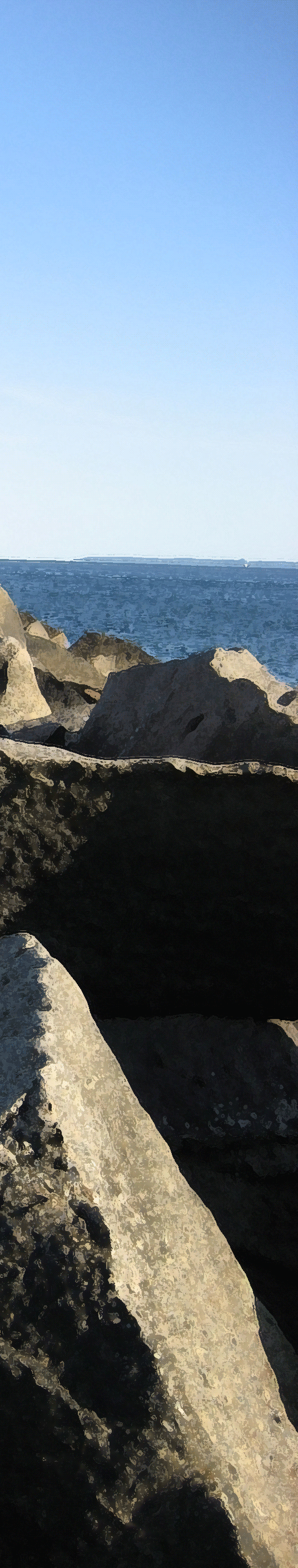 Aspetta il treno per Manhattan, così come lo aspetta un terzetto di lavoratori latinoamericani. Scenderanno tutti e quattro nella Manhattan meno scintillante: la stazione semideserta della Centoventinquesima Strada, nella Harlem nero-ispanica, sull’orlo della quale egli abita – in uno spazio di confine, uno spazio di iper-proletariato accademico senza iperboli. E si incamminerà verso casa nella frontiera temporale fra la notte e l’alba, fra una giornata americana che è passata e una nuova che comincia.
Aspetta il treno per Manhattan, così come lo aspetta un terzetto di lavoratori latinoamericani. Scenderanno tutti e quattro nella Manhattan meno scintillante: la stazione semideserta della Centoventinquesima Strada, nella Harlem nero-ispanica, sull’orlo della quale egli abita – in uno spazio di confine, uno spazio di iper-proletariato accademico senza iperboli. E si incamminerà verso casa nella frontiera temporale fra la notte e l’alba, fra una giornata americana che è passata e una nuova che comincia.
New York, 11 aprile 2009 (Sabato Santo)
In questi giorni ho riletto in fretta – e la fretta di (ri)lettura genera un complicato arabesco di punti d’intensità e punti di annebbiamento – due tesi di dottorato (una da me sponsorizzata, l’altra co-sponsorizzata), in preparazione alla loro discussione in sede di commissione: una riguarda il mito e alcune questioni connesse nell’opera di Cesare Pavese, e l’altra è dedicata a uno studio comparativo austriaco-triestino, con una serie di medaglioni dedicati a coppie di scrittori – Rilke e Slataper, Svevo e Kafka, P. A. Quarantotti Gambini e Joseph Roth, Musil e ancora Svevo.
Come scrive Lorenzo Da Ponte all’inizio delle sue Memorie, citando un detto ebraico che egli poi traduce in italiano: “E da’ miei discepoli imparai più che da tutti”. Rileggendo queste e simili dissertazioni, io mi aggiorno infatti sugli interessi dei giovani, sulle tematiche che più li attirano e impegnano. Un concetto che pervade entrambe le dissertazioni, e in quella pavesiana è presente fin dal titolo, è il concetto di identità – parola chiave (buzz word, per dirla popolarmente all’inglese) oggi negli studi letterari e non solo. Mi pare che vi siano due grandi retoriche dell’identità che si aggirano negli studi umanistici e sociali, due retoriche potenzialmente contraddittorie – ma da quando in qua ciò ha disturbato il gioco retorico?
Vi è innanzi tutto la retorica di origine modernistica dell’identità in crisi: l’io disperso e frammentato, la devoluzione dell’io, la (de)privazione dell’io, ecc. Ma circola anche una retorica ben diversa e più ottimistica: che riguarda la necessità di cercare, e la possibilità di trovare/costruire, una propria identità – in lotta suppostamente progressista verso le varie forze putativamente repressive della società.
 Che la prima retorica si svolga prevalentemente in ambito letterario-filosofico, e la seconda primariamente in ambito psicosociale, non cancella la similarità dei fenomeni di fondo cui esse si rivolgono – dunque non esime dal loro confronto; si tratta, in fondo, dei grandi fenomeni che avvalorano o dis-valorano la vita umana. Oggi sia l’identità frammentata sia quella ritrovata si disfano o sviluppano – si (di)sviluppano – soprattutto lungo una dimensione orizzontale; e sembra giunto il momento di chiederci se questa dimensione non possa risultare limitante.
Che la prima retorica si svolga prevalentemente in ambito letterario-filosofico, e la seconda primariamente in ambito psicosociale, non cancella la similarità dei fenomeni di fondo cui esse si rivolgono – dunque non esime dal loro confronto; si tratta, in fondo, dei grandi fenomeni che avvalorano o dis-valorano la vita umana. Oggi sia l’identità frammentata sia quella ritrovata si disfano o sviluppano – si (di)sviluppano – soprattutto lungo una dimensione orizzontale; e sembra giunto il momento di chiederci se questa dimensione non possa risultare limitante.
Il modernismo – si dice e si ripete – è qualche cosa di molto fluido, di variamente sfaccettato. Ma allora bisogna affrontare il contrasto centrale: la coniunctio oppositorum di modernismo e anti-modernismo. Per esempio, uno degli elementi di profonda originalità del modernismo così come esso si sviluppa in Italia è il progetto del Futurismo, laddove esso si interroga su un’integrazione verticale della ricerca di identità. La critica, per esempio, di Filippo Tommaso Marinetti all’eccessiva presenza dell’ “io” in poesia va raffrontata alla sua fiducia – quasi una fede – in un’integrazione comunitaria, a livello nazionale, dell’identità; e non deve essere confusa con una generica retorica modernistica sulla perdita d’identità, sull’ “io diviso”. La questione se questo si debba definire modernismo o anti-modernismo (o “altro modernismo” o, come io preferirei, retro-modernismo) è meno importante del riconoscimento della presenza del fenomeno in sé: una dialettica che accoglie spinte centripete e spinte centrifughe, impulsi “pro” e impulsi “contro”.
A questo punto della nostra storia, per uscire dall’insabbiamento postmodernistico, bisogna uscire (ripeto) dalla dimensione orizzontale dell’identità. L’anti-umanesimo frammentistico del modernismo e il polemico umanesimo psico-sociologico della retorica identitaria rimangono essenzialmente nella stessa dimensione orizzontale: cioè sono limitati a un “io” troppo puntuale, e sono esposti alla brezza esilarante del narcisismo (compreso il narcisismo negativo della delectatio più o meno morosa a proposito dell’io diviso). Di fronte a tutto ciò, va tenuta sempre aperta la possibilità di una identità orientata in direzione verticale, verso Qualcuno o 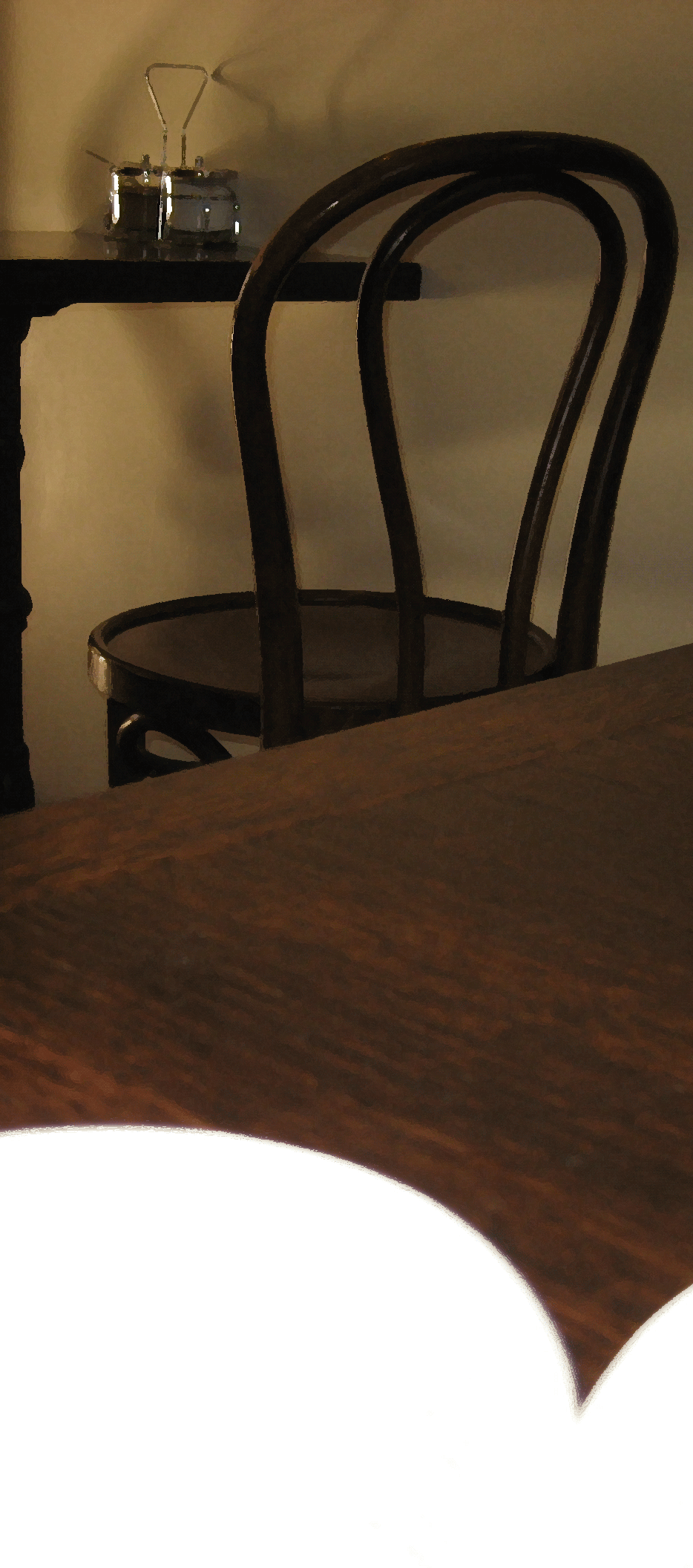 Qualcosa che trascende l’identità in quanto appiccicata alla pura immanenza. In fondo qui si misurano due concezioni diverse dell’antropologia: quella radicalmente laicistica e immanentistica, e quella invece che non dimentica il contesto teologico della filosofia.
Qualcosa che trascende l’identità in quanto appiccicata alla pura immanenza. In fondo qui si misurano due concezioni diverse dell’antropologia: quella radicalmente laicistica e immanentistica, e quella invece che non dimentica il contesto teologico della filosofia.
Uno dei prossimi appuntamenti di ricerca è quello di uno studio di ciò che accade al modernismo italiano negli anni Quaranta, mentre crolla il regime culturale che lo aveva bene o male (più o meno contradditoriamente) sostenuto, e deve d’altro canto ancora emergere il nuovo regime culturale che opporrà al modernismo una sorta di neoclassicismo ideologico (crocio-gramscismo, dominio lukaciano, ecc.). Per esempio, e tornando per un momento al grande autore evocato sopra: Marinetti nei suoi ultimi scritti, senza rinnegare il Futurismo e senza un’esplicita palinodia, comincia a elaborare una diversa antropologia dell’avanguardia, in modi che comunque restano creativamente sperimentali. Egli sposta la focalizzazione dalla integrazione comunitaria e specificamente nazionalistica dell’io (antropologia orizzontale) a un’integrazione almeno potenzialmente verticale. Marinetti infatti riporta in luce l’elemento spirituale del simbolismo, pur non rinnegando la propria attenzione di poeta e narratore verso la struttura direi molecolare della materia del mondo; con il risultato di una declinazione animistica (vedi Aeropoema di Gesù) dell’immaginario religioso.
 Bologna, 30 aprile 2009
Bologna, 30 aprile 2009
Anche da certi romanzi un po’ all’acqua di rose – quei romanzi diffusi oggi dalle editrici più chic, con un senso un poco ansioso della riscoperta a ogni costo – romanzi che comunque hanno una loro dignità media (dunque si differenziano dalla media-sotto-il-livello-medio di tanti romanzi che affollano il Premio Strega) – quei romanzi medio-europei scritti in una lingua abilmente elastica che si traduce subito da sola – romanzi che pur avendo (ripeto) una loro dignità non hanno il coraggio del rischio, il coraggio della “bruttinità” (come un amico poeta ha avuto la non-bontà di dire, definendo alcune delle mie poesie) – anche da quei romanzi emergono ogni tanto alcune frasi che si fanno ricordare. (Ecco perché io continuo a essere un umile, avido, indiscriminato lettore.)
“‘Sono forse invecchiata, Mark?’ domandò bruscamente […] Lui crollò il capo: ‘Non lo so. Credete che si guardi il volto della donna amata? Si vede al di là dei suoi lineamenti. Si pensa: – Mi farà soffrire ancora di più, oggi? O si stancherà finalmente di farmi penare, e mi amerà? –. Come vedete, anche al colmo della passione si continua a pensare solo a se stessi’.” (Irène Némirovsky, Jezabel, trad. L. F. Guarino, Milano, Adelphi, 2007 [Parigi, 1936], p. 81).
Bologna, 1 maggio 2009
Un’ultima citazione, ancora più breve, dal succitato romanzo, che ho cominciato ieri e che oggi ho finito – ma questa volta la frase chiama un commento:
“Si svegliava sul far della notte, assaporando con un piacere disperato l’orrore del crepuscolo parigino” (op. cit., p.176)
Basta una frase, a volte, a far scattare tutta una serie di riflessioni – o forse sono semplicemente (semplicemente?!) immagini. La prima “riflessione” riguarda il referente della frase citata. Le mie visite a Parigi, pochissime e distantissime nel tempo, non mi consentono di verificare la “pariginità” di un crepuscolo – ma capisco meglio la frase se la riporto ai crepuscoli di un’altra grande città in cui ho passato e passo anni decisivi, tanto che oserei chiamarla la mia città: New York; e soprattutto la capisco meglio se penso ai crepuscoli di New York nei capitoli precedenti della mia vita: i capitoli di fine Novecento, quando la mia solitudine era ancora una solitudine tanto avida quanto disorientata.
Mi ricordo, allora, quando al crepuscolo contemplavo le interminabili file dei ritornanti dal lavoro, dal finestrone che era l’unica cosa grande nel mio monolocale sbilenco al primo piano del casamento sulla Quarantottesima Strada, di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite. E sì: c’era qualcosa di orribile (ma allora avevo paura ad appplicare anche solo mentalmente quella parola a ciò che vedevo) – qualcosa di orribile e di bello in quei crepuscoli quando non sapevo bene dove fossi veramente, e non avevo la minima idea di come sarei potuto andare a finire, e non avevo nessuno cui confidare questo mio disorientamento, e sentivo in effetti il bisogno di confidarlo ma poi finivo col rassegnarmi al fatto che questo bisogno restasse insoddisfatto, e la rassegnazione mi rendeva più calmo e migliorava la qualità della contemplazione; ecco, forse era tutta questa mescolanza a definire l’orrorino elegiaco di quei crepuscoli.
 Adesso i miei crepuscoli newyorchesi non sono orribili, ma d’altra parte non sono più fonte di particolare piacere. Non è che io sia divenuto molto più sicuro di dove veramente io sia, nella vita, ma non sono più tanto agitato al pensiero di dove e come finirà – il fiume Hudson che adesso vedo dalla mia (alta, questa volta) finestra mi sembra la foce della mia vita. E tuttora non ho veramente nessuno con cui confidarmi giorno dopo giorno, ma la differenza è che adesso ho rinunziato all’utopia della confidenzialità.
Adesso i miei crepuscoli newyorchesi non sono orribili, ma d’altra parte non sono più fonte di particolare piacere. Non è che io sia divenuto molto più sicuro di dove veramente io sia, nella vita, ma non sono più tanto agitato al pensiero di dove e come finirà – il fiume Hudson che adesso vedo dalla mia (alta, questa volta) finestra mi sembra la foce della mia vita. E tuttora non ho veramente nessuno con cui confidarmi giorno dopo giorno, ma la differenza è che adesso ho rinunziato all’utopia della confidenzialità.
Pensandoci bene, poi, è diventato raro per me vedere ancora i crepuscoli: di solito mi cadono addosso silenziosamente – senza particolare violenza, senza particolare fascinazione – mentre sono ancora in ufficio, immerso nel lavoro. Si potrebbe anzi dire che ho riscoperto la bellezza senza l’orrore, nei crepuscoli newyorchesi (è uno dei vantaggi di quel generale svantaggio che è l’età). Perché in fondo i crepuscoli mi capita di vederli soprattutto nelle rare occasioni in cui ripasso dal mio appartamento interrompendo più presto del solito la mia giornata d’ufficio, per cambiarmi e uscire. Sono le mie rare “ore d’aria” in cui veramente ritrovo la mia città – la città della mia matura giovinezza – la città di cui sentivo (nel mio vigore disorientato) la bellezza mista a orrore; la città che invece adesso vedo il più delle volte come attraverso un velo – un velo che smussa i contrasti e smorza le asprezze, che mi dà ancora il senso della contemplazione: ma questa volta è una contemplazione serena, una contemplazione contemplativa. Tutto bene, dunque – anche se non posso nascondermi che questa serenità è al tempo stesso una forma di rassegnazione, una rinunzia alle passioni.
La seconda (e ultima) riflessione è che non posso non guardare alla frase citata sopra anche da un punto di vista più tecnicamente letteraio. Essa può funzionare in effetti come metonimia dell’intero romanzo: un po’ melodrammatico, e abbastanza in ritardo rispetto al graffio ben più originale e forte di una scrittura protonovecentesca come quella, per esempio, di d’Annunzio. Jezabel infatti ricorda un episodio del Fuoco di d’Annunzio (quello della donna che a un certo punto si clausura nel suo palazzo perché nessuno possa essere più testimone dello sfiorire della sua bellezza), e ricorda anche tutta la trama di un bel romanzo di Massimo Bontempelli del 1930, Vita e morte di Adria e dei suoi figli (che in effetti sembra essere fiorito, come una pianta completa, dal bocciòlo di quell’episodio dannunziano).
Ma allora, si può fare una distinzione bella netta e pulita fra la riflessione che ho appena fatto (critica letteraria) e la “riflessione” sui crepuscoli di New York (impressioni diaristiche)? Io non credo. Per dirla all’inglese, “Literary criticism is as literary criticism does”, che si potrebbe tradurre dicendo che: La critica letteraria consiste in quello che di volta in volta la critica letteraria nella sua effettività (nella sua pratica o praticaccia) fa. Il ruolo che ho in mente, in fondo, è quello che si potrebbe chiamare: un lettore radicalmente umanistico.
 Venezia, 10 maggio 2009
Venezia, 10 maggio 2009
Al termine di una visita alle Gallerie dell’Accademia che non vedevo da quasi una mezza vita e che restano un enorme scrigno di tesori, appunto due sintetiche riflessioni.
Presenza (e non) della spiritualità
Nelle tavole di pittura precedenti il periodo dei Bellini, il divino è presente, anche se in una forma istituzionale e arcigna; lo spettatore inchina per un attimo mentalmente il capo (un rispetto formale), e poi si diverte a esaminare i dettagli. Ma soltanto quando si arriva alle Madonne di Giovanni Bellini, il senso della divinità compenetra le immagini con dolce forza convinta e pervasiva, come meditazione costante sul colloquio Madre-Figlio. Poi, questo senso scompare. Tiziano (perfino Tiziano), Tintoretto, Veronese, Tiepolo: una serie di immagini stupende e sontuose, dove c’è un’impalcatura mentale piuttosto che spirituale – un’impalcatura che rinvia a una trascendenza la quale peraltro essenzialmente non si sente. (Sto parlando dei quadri dell’Accademia, non generalizzando sopra questi maestri: basti pensare ai Tintoretto della Scuola di San Rocco, all’appassionata “Salita al Calvario” di Giambattista Tiepolo nella chiesa di Sant’Alvise; per non parlare della “Via Crucis” modernamente intensa del figlio Giandomenico Tiepolo nella chiesa di San Polo, che aprirebbe tutto un discorso sulla persistenza della spiritualità nella Venezia settecentesca, la cui atmosfera non è solamente casanoviana; ecc. ecc.). Qui comunque bisognerebbe rivisitare il grande e partigiano libro scritto a metà Ottocento da John Ruskin, The Stones of Venice: gli attacchi anti-rinascimentali di Ruskin sembrano avere una base soprattutto teologica – il che conferma (si sia d’accordo oppure no con il suo contenuto) l’importanza della valutazione spirituale.
 L’unico altro complesso di opere (non parlo dunque, o almeno non primariamente, di opere singole) nelle Gallerie dell’Accademia in cui chiaramente traspare il senso del divino appartiene anch’esso, come il Bellini, al Quattrocento: si tratta dei quadri di Carpaccio – dove il divino appare sotto forma di visionario incantamento ipnotico, in particolare nel “Sogno di Orsola”. Si entra in quel quadro come in una stanza da cui è difficile uscire. Non è propriamente una scena in cui “si fa silenzio” – espressione che implica un rumorio di parole immediatamente precedenti. Qui invece le parole si sono taciute da tempo. Orsola vi appare come già profondamente addormentata, e si sente che l’Angelo sulla soglia non sta dicendo nulla, ma trasmette direttamente immagini silenziose alla mente di Orsola. È dunque un quadro che (come dicevo) piuttosto che far silenzio, fa del silenzio: esso crea il silenzio come se fosse un’esperienza della prima volta. Per tutto il resto di questa grande passeggiata lungo quadri stupendi che fanno pensare e che suscitano profondi piaceri, non trovo tuttavia il senso del divino, se non in alcune flagranti eccezioni (come l’“Annunciazione” di Antonello da Messina, peraltro collocata in modo sciatto).
L’unico altro complesso di opere (non parlo dunque, o almeno non primariamente, di opere singole) nelle Gallerie dell’Accademia in cui chiaramente traspare il senso del divino appartiene anch’esso, come il Bellini, al Quattrocento: si tratta dei quadri di Carpaccio – dove il divino appare sotto forma di visionario incantamento ipnotico, in particolare nel “Sogno di Orsola”. Si entra in quel quadro come in una stanza da cui è difficile uscire. Non è propriamente una scena in cui “si fa silenzio” – espressione che implica un rumorio di parole immediatamente precedenti. Qui invece le parole si sono taciute da tempo. Orsola vi appare come già profondamente addormentata, e si sente che l’Angelo sulla soglia non sta dicendo nulla, ma trasmette direttamente immagini silenziose alla mente di Orsola. È dunque un quadro che (come dicevo) piuttosto che far silenzio, fa del silenzio: esso crea il silenzio come se fosse un’esperienza della prima volta. Per tutto il resto di questa grande passeggiata lungo quadri stupendi che fanno pensare e che suscitano profondi piaceri, non trovo tuttavia il senso del divino, se non in alcune flagranti eccezioni (come l’“Annunciazione” di Antonello da Messina, peraltro collocata in modo sciatto).
A proposito di profondi piaceri, vengono in mente le parole che in un grande racconto Camillo Boito pone in bocca alla sua eroina, la contessa Livia; la quale, durante gli anni della sua giovinezza veneziana, condotta a visitare l’Accademia, dice: “non ci capii quasi nulla”, per poi aggiungere che da allora “qualche cosa ho imparato”. Ma ciò che conta è la vivace descrizione di quell’allora:
“ma allora, benché non sapessi niente, quell’allegrezza di colori, quella sonorità di rossi, di gialli, di verdi e di azzurri e di bianchi, quella musica dipinta con tanto ardore di amor sensuale non mi sembrò un’arte, mi sembrò una faccia della natura veneziana; e le canzoni, che avevo udito cantare dal popolo sboccato, mi tornavano nella memoria innanzi alla dorata Assunta di Tiziano, alla Cena pomposa di Paolo, alle figure carnose, carnali e lucenti del Bonifacio”. (Cito da Camillo Boito, Senso, nell’edizione accompagnata dal commento di Clotilde Bertoni, Lecce, Manni, 2002, p.27; questo racconto geniale va recuperato nella sua originarietà e originalità, al di là dell’abile edulcorazione rosa – in entrambi i sensi della parola – del film di Visconti.)
Livia è assai probabilmente quella che la critica letteraria chiama un unreliable narrator, ovvero ‘narratrice inaffidabile’ – nel senso che qui l’autore (architetto e critico d’arte, oltre che scrittore) intenderebbe far emergere la voce di una persona troppo immersa nell’immediatezza della percezione sensuale, e che dunque vede le opere d’arte in modo riduttivo. Ma la finzione narrativa è un gioco assai complesso, che può avere effetti da boomerang: le osservazioni ingenuamente dirette di una (inventata, ma bene inventata) contessina ventenne alla fine dell’Ottocento realizzano in fondo una critica ancora valida, come si è appena visto (senza contare che anche in quell’ “allora” giovanilistico la contessa è ingenua solo fino a un certo punto: la sua sensibilità sinestetica – “musica dipinta” – è già di tipo simbolistico).
 Ma torno alle eccezioni – alle emersioni della spiritualità. Fra queste eccezioni annovero in particolare la straordinaria “Presentazione della Vergine al Tempio” di Tiziano – uno sghembo quadro in salita obliqua che è una delle ultime vedute (in questo caso, è anche una visione) che incontrano lo sguardo di chi sta per uscire dalle Gallerie, alla fine della visita. (A proposito: le Gallerie dell’Accademia sono, nella loro attuale forma, piuttosto grigie e impersonali, e appaiono bisognose di un restauro – che peraltro è già annunziato e abbondantemente illustrato; si spera soltanto che questa non sia la scusa per chiudere le Gallerie per lungo tempo nel prossimo futuro: è ormai chiaro che è possibile in molti casi simili condurre a termini i lavori con efficienza pur mantenendo parzialmente in funzione le istituzioni coinvolte.)
Ma torno alle eccezioni – alle emersioni della spiritualità. Fra queste eccezioni annovero in particolare la straordinaria “Presentazione della Vergine al Tempio” di Tiziano – uno sghembo quadro in salita obliqua che è una delle ultime vedute (in questo caso, è anche una visione) che incontrano lo sguardo di chi sta per uscire dalle Gallerie, alla fine della visita. (A proposito: le Gallerie dell’Accademia sono, nella loro attuale forma, piuttosto grigie e impersonali, e appaiono bisognose di un restauro – che peraltro è già annunziato e abbondantemente illustrato; si spera soltanto che questa non sia la scusa per chiudere le Gallerie per lungo tempo nel prossimo futuro: è ormai chiaro che è possibile in molti casi simili condurre a termini i lavori con efficienza pur mantenendo parzialmente in funzione le istituzioni coinvolte.)
Nel quadro tizianesco, il cui protagonista strutturale è una lunga scalinata che al tempo stesso fende e salda l’immagine, il centro non-centrico è la figura della Vergine: tradizionalmente iconografica nella sua veste turchina, ma rappresentata come una bambinetta, con un bellissimo contrasto fra questo piccolo corpo indifeso (visto di tre quarti e di spalle, così che la faccia risulta invisibile) e la torreggiante figura del sacerdote carico di paramenti che l’attende al culmine della scalea, in fondo a destra. Certo, questa bambina a metà scalinata si rivela subito come differente e distinta: l’aureola che le circonfonde il capo, e la profonda attenzione degli astanti in fondo alla scala a sinistra, mostrano che qualche cosa di speciale, di diverso dal solito ritmo dei giorni, sta per accadere.
Ma non basterebbe l’aureola intorno alla testolina a presentificare il divino dentro questo quadro. (Le Gallerie sono piene di teste aureolate e di corpi reggenti simboli solenni; ma in generale, come detto, questi restano ornamenti eleganti che non penetrano “l’altra dimensione”.) La genialità dell’artista consiste qui soprattutto nella concentrazione e compattezza del corpo della bambina, da cui emana un senso di forza: la sua salita è una vera e propria marcia. Ho sempre trovato commoventi (nell’arte e nella vita – nell’arte/vita) i bambini quando essi manifestano la precocità di una vocazione, di qualunque vocazione (spirituale o mondana) si tratti. E non conosco altra opera di pittura che prefiguri così vividamente l’idea della Immacolata Concezione secoli prima che essa venga teologizzata in dogma – cioè in nucleo sistematico di pensiero. (È da queste opere che bisognerebbe partire, per svolgere una meditata critica del nesso che il citato Ruskin eloquentemente ma restrittivamente stabilisce tra spiritualità e teologia protestante, con frecciate anti-cattoliche.)
L’unica altra forte eccezione a questo appiattimento della spitualità che io ricordi all’Accademia è la “Cena di Emmaus” di un artista di quelli antipaticamente detti “minori” (e mi dispiace non ricordarne il nome, perché non vorrei incoraggiare nemmeno indirettamente certe gerarchie manualistiche). In quel quadro, la spiritualità non emerge né dalla figura del Cristo né da quelle dei due pellegrini (immagini rigide e non particolarmente espressive), ma dalla figura della serva o schiava mora, ritta a sinistra accanto al Cristo. È un’africana giovane, vestita di colori particolarmente vivaci (in cui predominano se ben ricordo – sto scrivendo a memoria, e vari giorni dopo la visita – il rosso e il giallo). Ma quello che è straordinario è il suo sguardo, così difficile da descrivere – e del resto (a parte il citato problema della descrizione a memoria) se fosse facile descriverlo in parole la performanza pittorica non sarebbe così notevole. Lo sguardo della giovane è rassegnato e paziente, tanto che potrebbe a prima vista sembrare scettico; e invece non lo è – è uno sguardo che sembra dire: ‘Sì, io lo so che certe cose possono essere segni; ne ho visti qualche volta, nel villaggio dove sono nata; e so anche quanta fatica costano: ciascuno di questi segni è un bruciamento di vita, e rischia di essere frainteso, e subito dimenticato’. Per parte mia, ricorderò a lungo quello sguardo.

Permanenza di Venezia
Tutti i panorami veneziani visibili lungo le pareti dell’accademia, dal Bellini – e anche prima di lui – all’abbastanza noioso Canaletto (e anche dopo di lui) sono storicizzabili in un duplice senso: che possono essere storicizzati (nel senso della storia dell’arte – cioè pensando a essi quadri piuttosto che a Venezia), e che al tempo stesso debbono essere storicizzati in un senso antropologico generale (dunque pensando a Venezia piuttosto che a queste sue rappresentazioni). Cioè: la Venezia che essi rappresentano non c’è più – o più precisamente, può essere oggetto solo di una ricostruzione fantasmatica. (Mi permetto di distinguere qui tra “fantasmatica” e “fantastica”: quest’ultima è la ricostruzione che lo spettatore dei quadri effettua in termini storico-artistici, ovvero in quanto para-storico dell’arte; la prima invece è la ricostruzione parallela che lo spettatore, in quanto uomo della strada o uomo quotidiano, effettua con riferimento a Venezia come oggetto della rappresentazione, confrontando la Venezia di una volta, che sta contemplando in quei quadri, con la Venezia come adesso lui effettivamente la conosce.)
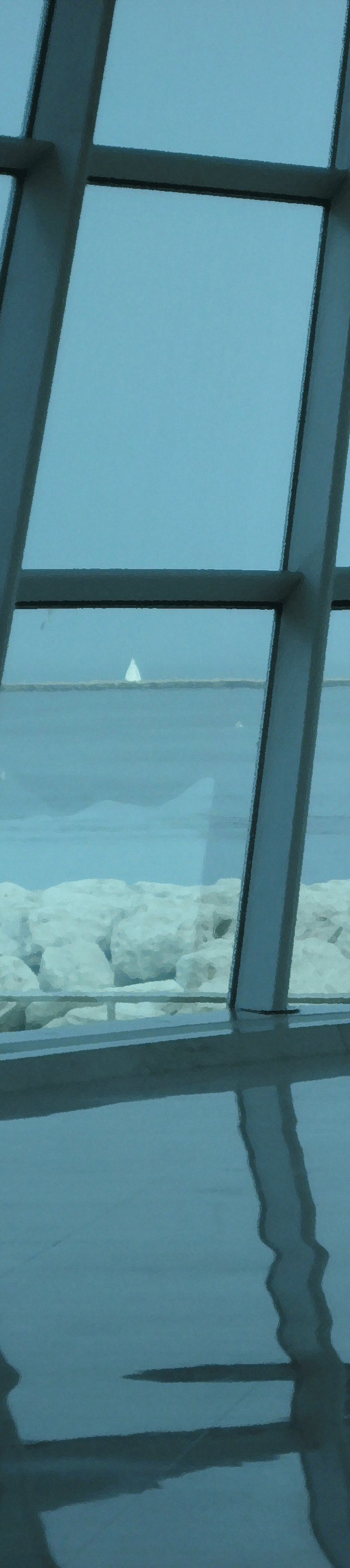 Tutte storicizzabili, dunque, queste vedute veneziane – con una flagrante e sfolgorante eccezione: “La tempesta” di Giorgione. Non pretendo certo di addentrarmi nell’enorme letteratura scientifica su questo quadro. Vorrei soltanto dire che, a mio umil parere, il punto più geniale di questo geniale dipinto è il suo aver scavato fuori quella che si può chiamare un’ontologia di Venezia.
Tutte storicizzabili, dunque, queste vedute veneziane – con una flagrante e sfolgorante eccezione: “La tempesta” di Giorgione. Non pretendo certo di addentrarmi nell’enorme letteratura scientifica su questo quadro. Vorrei soltanto dire che, a mio umil parere, il punto più geniale di questo geniale dipinto è il suo aver scavato fuori quella che si può chiamare un’ontologia di Venezia.
La grandezza del quadro infatti resta intatta anche a prescindere dai suoi elementi in primo piano – che restano affascinanti, e che ne costituiscono il permanente enigma: il soldato (?), fallico ma con discrezione (non è un ossimoro), appoggiato alla lancia sulla sinistra e la donna seminuda, erotico-zingaresco-materna, sulla destra. Sono affascinanti, come detto, per la loro presenza estetica e anche perché incoraggiano un’esegesi più o meno allegorica; ma vi è in essi anche – oso dire – qualche cosa di irrisolto, di gratuito.
Ciò accade forse perché il vero protagonista del quadro (ecco perché invitavo a prescindere) è lo sfondo – come lo stesso titolo tradizionale, “La tempesta”, viene a riconoscere. Semplicemente (cioè: tutt’altro che semplicemente), un canale veneziano di periferia su cui si addensa dal cielo il temporale. Quella che mi sono azzardato a chiamare l’ontologia di Venezia fa tutt’uno con la non-storicizzabilità di questo paesaggio. Nel senso che, a differenza degli altri lungo le Gallerie, il paesaggio lì presente può non essere relegato (non deve essere relegato) alla storia: esso è a ancora qui tra noi; è come una pre-fotografia visionaria, incisa sulla lastra dello spirito, di Venezia, oggi come ieri – in un oggi che non conosce un “ieri”, così come non conosce un “domani”.
Paolo Valesio
New York
Codex atlanticus, 10
Bologna, 10 novembre 2007
Trascrivo la parte conclusiva di una lettera inviata all’amico J. R. (poeta di origine non italiana ma perfettamente italòfono – con due linguemadri rivali):
“L’esito disastroso di un paio di recenti conversazioni politiche e l’isolamento in cui sono venuto a trovarmi, mi hanno convinto ad adottare il silenzio sull’argomento. Il mio caso personale non è importante, ma è il sintomo di un più vasto e grave fenomeno, che trattiene l’Italia al di qua della soglia del pieno ingresso nella moderna civiltà politica: la persistente difficoltà ad ammettere che non tutti gli intellettuali italiani siano schierati da una certa parte politica.
“Non so se conversazioni di questo tipo potranno essere riprese; forse ciò potrà avvenire soltanto quando ci troveremo a sedere sulle macerie della guerra civile tiepida (più tumultuante dunque della guerra civile fredda che finora è andata strisciando per l’Italia, ma meno forte di una guerra civile calda che – mi auguro fervidamente – non avrà mai luogo). Parlo di quella guerra civile tiepida – guerra elettorale – che si scatenerà in Italia, e in modo particolare a Bologna, nel prossimo anno o due.
“Scrivendo queste frasi, mi balza improvvisamente in mente un’immagine: quella di un poeta nel solco e tradizione di Omero (li chiamavano, come tu sai bene, gli Omèridi) – un Omèrida, dunque, che accorda la sua cetra sulle rovine della guerra civile. Questo tipo di poesia non è nelle mie corde, come suol dirsi; ma lo è nelle tue (lo dico in tutta sincerità), come il poeta modernamente epico che tu sei. Il filino di dubbio che mi resta a questo proposito non riguarda la tua abilità poetica, bensì la questione ideologica. Uno degli elementi essenziali della grandezza omerica è il senso di equidistanza fra gli Achei e i Troiani. (E’ certo da tenere in conto l’intuizione di Simone Weil quando definisce l’Iliade come il poema della forza; ma esso è anche, suggerirei io, il poema della conciliazione sulle rovine.) Verrà mai un Omèrida italiano che canti equanimemente la Destra e la Sinistra?”
North Branford (Connecticut), 3 febbraio 2008
Stamattina dopo la messa a North Branford passo dal paesino accanto, che si chiama Branford (è comunque più grande di North Branford, che è semplicemente un villaggio); e mi avvio (dopo il rito sacro) al mio piccolo rito personale e profano del “brunch” in una caffetteria di Branford, dove l’ingannevolmente semplice menù tradizionale del “brunch” americano è realizzato con una gustosità ben superiore a quella degli altri locali dela zona. Parcheggio l’automobile e percorro le poche centinaia di metri di marciapiede che mi separano da quel locale (il quale, con sprezzatura tautologica, si chiama semplicemente “Coffee Shop”).
 All’angolo, mi sorprende uno spettacolo insolito: una donna bionda sulla trentina sta dritta in piedi sull’orlo della strada reggendo un cartello striato dei patriottici colori bianco-rosso-blu dove campeggia il nome di uno dei due politicanti in lotta per la candidatura ufficiale del Partito Democratico alla presidenza USA – il nome di Hillary Clinton. Accanto a lei una bambina, evidentemente sua figlia, sta giocherellando – con quel misto di noia e orgoglio e imbarazzo che i bambini mostrano quando si trovano a essere coinvolti in qualche insolita attività di uno o entrambi i genitori. Di ritorno, una mezz’oretta più tardi, dal “brunch” trovo che la donna, con la bambina appresso, è ancora lì: ritta in quell’angolo strategico del marciapiede, dove i passanti (radi) e gli automobilisti (abbastanza numerosi) possano vedere bene il cartello con il nome della sua eroina politica.
All’angolo, mi sorprende uno spettacolo insolito: una donna bionda sulla trentina sta dritta in piedi sull’orlo della strada reggendo un cartello striato dei patriottici colori bianco-rosso-blu dove campeggia il nome di uno dei due politicanti in lotta per la candidatura ufficiale del Partito Democratico alla presidenza USA – il nome di Hillary Clinton. Accanto a lei una bambina, evidentemente sua figlia, sta giocherellando – con quel misto di noia e orgoglio e imbarazzo che i bambini mostrano quando si trovano a essere coinvolti in qualche insolita attività di uno o entrambi i genitori. Di ritorno, una mezz’oretta più tardi, dal “brunch” trovo che la donna, con la bambina appresso, è ancora lì: ritta in quell’angolo strategico del marciapiede, dove i passanti (radi) e gli automobilisti (abbastanza numerosi) possano vedere bene il cartello con il nome della sua eroina politica.
Sarebbe troppo facile fare dell’ironia. Troppo facile soprattutto per chi trova impresentabili i candidati del Partito Repubblicano e insopportabili quelli del Partito Democratico; troppo facile anche per chi pensa che questo nobile sforzo (volontario, gratuito, precoce, isolato) avviene in favore di una persona che – come tutte le altre che con lei gareggiano – si è fatta depersonalizzare, divenendo la creazione o creatura di una grande macchina politico-finanziaria che macina e vomita miliardi di dollari per costruire simulacri politici; troppo facile infine per chi presti ascolto a certi Soloni della politologia e della statistica i quali vanno spiegando che il voto del singolo non conta (in tutti i sensi del termine) essenzialmente nulla.
Ma tutte queste considerazioni (credo esatte le prime due, eticamente falsa la terza) mancano fondamentalmente il bersaglio. Questa signora, evidentemente di classe medio-alta, giovane e carina, che offre la sua testimonianza politica isolata e ne rende partecipe la figlia, trascende i vari ideologismi (clintoniani, femministi, e simili) che riempiono l’aria con il loro chiacchiericcio tra il furbo e l’ingenuo. Costei è testimone di quella cosa ibrida, contraddittoria e fondamentalmente grottesca, ma indispensabile, che è il sistema politico della democrazia nel suo inevitabile rimescolamento con la demagogia. E la sua piccola figlia che sta lì ad annoiarsi lungo il marciapiede certo si sente anche, in qualche modo istintivo, orgogliosa (come dicevo) di quella cosa strana e non priva di coraggio che questa donna sta facendo: la sua mamma, nientemeno, si espone al ridicolo (cosa che bambini hanno in orrore). In ogni caso, questo è un momento importante nell’educazione della bambina, la quale si ricorderà per lungo tempo di questa mattina domenicale. Che forse rimarrà un anello importante nella catena di storie racontate in famiglia, forse sarà il germe di una vocazione all’impegno politico; o forse cadrà come suol dirsi nel dimenticatoio (com’è fatto, il dimenticatoio? come quella che nella mia famiglia si chiamava “la camera buia”: un ripostiglio di cassette e pacchetti, di cose utili da usare ma anche di cose inutili?) – per poi forse riapparire improvvisamente nei suo ricordi: una mattina rispolverata e scintillante, una di quelle immagini alle quali un’anziana signora amerà ritornare nel suo discorrere.
Manhattan, 15 aprile 2008
Stamattina leggo in simultanea la prima pagina del Corriere della sera e l’articolo in alto a sinistra nella prima pagina del New York Times: questa scena ripete, con quasi allucinante precisione, quella di meno di due anni or sono, il 14 aprile 2006 [vedi Codex Atlanticus numero 9, in Anfione e Zeto 20 (Gennaio 2008), pp. 211-217]. Ma la somiglianza si ferma qui; perché i risultati elettorali si sono completamente rovesciati: vittoria “storica” (come dicono le gazzette) del centrodestra, con risultati da record della Lega perfino in regioni come l’Emilia-Romagna; nessuno dei partiti etichettato “comunista”, e nemmeno quello socialista, sono riusciti a entrare in Parlamento: è la prima volta che ciò accade, nella storia della Repubblica. (La Repubblica, il Paese – così maiuscolano le gazzette, che non osano più maiuscolare Nazione; e mi viene sempre in mente la marca di formaggio “Bel Paese”.)
Ma che cosa vuol dire poi, “risultato storico”? Qualche cosa che pochi avevano visto venire da lontano, e che avevano capito – mentre i più avevano rimosso, e rifiutato di capire. In quel giorno di aprile del 2006 avevo scritto un distico della cui poeticità non meno vanto, ma che trascrivo perché molte profezie si sono espresse nei tempi in versi similmente modesti:
Entro un anno
se ne vanno.
Tornando dal ridicolo al serio: mi sto occupando delle mie reazioni come un experimentum in corpore vili. Vale a dire (per riprendere una distinzione che ho sviluppato altrove) che le sto descrivendo non tanto in quanto simboliche di una situazione (nel senso di atteggiamento originale e significativo, qualcosa che occupi il centro del palcoscenico, che esprima una posizione sovrastante, di controllo); quanto piuttosto come sintomatiche di questa situazione, nel senso di offrire il resoconto di cose che capitano a un individuo qualunque, dunque rappresentativo. (Il simbolo tende all’eccezionalismo troppo voluto, alla demagogia; mentre il sintomo è connesso alla mediocritas della democrazia.) È questa, in sostanza, la giustificazione dei dettagli che seguono: essi non sono drammaticamente rivelatori, ma appunto per questo possono risultare funzionali a un’analisi modestamente concreta.
Quei due versicoli erano anche un piccolo tentativo di esorcizzare una delusione – un tentativo di autoconsolazione. Poi, in quella stessa mattinata dell’aprile 2006, la delusione si era tradotta in desiderio di raccoglimento, di distanziazione dalla politica (dunque, raccoglimento contro accoglimento). Ma poi, il giorno seguente, il rovesciamento: una ripresa di interesse per la politica, all’insegna di un atteggiamento di cittadino non allineato, di maverick [vedi la citata sezione numero 9 di Codex Atlanticus]. Altro rovesciamento nel corso del 2007: prende forma un vero e proprio distacco dalla passione politica. Mi sia permesso citare un paio di frasi dal mio Diario quotidiano, il giorno del Sabato Santo (7/4/07), dopo aver partecipato nel corso della giornata precedente a una grande processione della Via Crucis che aveva percorso il Ponte di Brooklyn: “Un primo effetto dell’esperienza quasi mistica di ieri mattina è maturato tra ieri sera e stamattina: mi sono lasciato alle spalle la politica – ne ho perduta la passione; ma non è un fenomeno puramente negativo …” .
Infatti, questo allontanamento dalla passione politica rappresentava uno sviluppo spirituale, ma non era una forma di indifferenza verso l’analisi politica – su cui continuo a ragionare, con riferimento sia alla politica italiana sia a quella statunitense. “Ragionare” però è una parola troppo fredda e astratta, che non dice pienamente la mia esperienza: un’esperienza partecipativa, con l’immaginazione e oso dire con il cuore, oltre che con il voto.
Quello che si sarebbe dovuto scorgere già alla fine degli anni Novanta, ma che pochissimi volevano vedere, era l’inizio della fine di tutta una cultura politica, che aveva dominato l’immaginazione italiana ininterrottamente dal 1945: quella cultura politica che esaltava l’ideologia come se fosse un elemento positivo – quella cultura che interpretava il concetto (potenzialmente esplosivo) di “critica dell’ideologia” come critica dalla ideologia, cioè a partire da una ideologia specifica; dunque: non una critica che fosse decostruttiva di tutte le formazioni ideologiche, ma una critica che l’ideologia più-o-meno marxista svolgeva di tutte le ideologie che non fossero lei.
 Allora, negli anni Novanta, era questa capacità di vedere tutto un nuovo movimento anti-ideologico, un movimento in fieri dentro la società – era questa, l’intuizione propriamente storica; dove intuizione storica significa appropriatamente: scavo di ciò che è celato nelle pieghe della società e nei ritmi del tempo. Non come adesso, dove (ripeto) “storico” – in riferimento a questo crollo di tutta una cultura politica – significa qualche cosa di tautologico e banalizzante: la constatazione di ciò che è già diventato chiaro.
Allora, negli anni Novanta, era questa capacità di vedere tutto un nuovo movimento anti-ideologico, un movimento in fieri dentro la società – era questa, l’intuizione propriamente storica; dove intuizione storica significa appropriatamente: scavo di ciò che è celato nelle pieghe della società e nei ritmi del tempo. Non come adesso, dove (ripeto) “storico” – in riferimento a questo crollo di tutta una cultura politica – significa qualche cosa di tautologico e banalizzante: la constatazione di ciò che è già diventato chiaro.
Quando prendo le distanze dagli intellettuali più o meno “organici” intendo distanziarmi dalla loro ideologia, non dalla loro umanità. Questo senso dell’umanità è stato forse il chiarimento più netto emerso da quella minuscola epifania del sabato santo 2007 che ho ricordato sopra. (Intendo la umanità dei singoli, non quella astratta delle utopie social-totalitarie; per spiegarmi: io scrivo sia “umanità” sia “singolo” con la minuscola, ma è quando pronunzio/scrivo il secondo termine, non quando pronunzio/scrivo il primo, che mi viene a volte di pensare un’iniziale maiuscola, come la usa Kierkegaard nei suoi Diari, quando scrive “il Singolo”.) Così accade che, senza (rin)negare una punta di soddisfazione per essere stato in sintonia con gli sviluppi storici che hanno portato all’aprile del 2008, io non mi senta peraltro di gongolare, perché penso alle persone care e agli amici che in questi giorni sono amareggiati dalla delusione dei loro desideri.
Penso alle mie due familiari che erano andate a votare nella Sala Rossa (rossa nel senso della decorazione) del Comune, nel cuore e centro della nostra città di Bologna, e avevano votato “rosso” in un senso tutt’altro che decorativo. Penso alla moglie di un amico, rappresentante di uno dei partitini comunisti, la quale ha perso il suo seggio in parlamento. Penso (per citare una scelta elettorale in un certo senso opposta alle due appena descritte) a quell’amica, espatriata come me, che in mia presenza – e a differenza del modo in cui stavo votando io – ha votato scheda bianca: ha attentamente “riempito” (cioè svuotato) in bianco la scheda che ha poi infilato nella busta diretta al Consolato di New York. Penso a loro, e altre persone nella stessa situazione; e questi pensieri temperano e moderano e ridimensionano la mia soddisfazione politica.
Che poi quasi tutti i miei amici e colleghi (a eccezione delle persone evocate sopra) non siano disposti a trattarmi allo stesso modo – che anzi siano prontissimi, quando si prenderanno la rivincita elettorale, al sarcasmo trionfalistico – tutto questo fa parte del paradosso in cui vive il maverick; si potrebbe anche chiamarlo il paradosso della benevolenza, o dell’altruismo, o addirittura della caritas. (Ma un termine forte come quest’ultimo non può essere usato senza subito precisareche esso pone una meta tanto essenziale quanto essenzialmente inattingibile – o almeno, non pienamente raggiungibile da parte dell’autore di queste righe.) Tornando comunque al panorama generale: ciò che conta è il singolo, e l’amicizia vince sulla politica; più precisamente: la politica interseca e intesse l’amicizia, si vena di amicizia.
Manhattan, 17 aprile 2008
 Sento che debbo ritornare su quello che ho scritto due giorni fa; il fatto è che vorrei spiegarmi meglio.
Sento che debbo ritornare su quello che ho scritto due giorni fa; il fatto è che vorrei spiegarmi meglio.
La politica avviene dentro la polis, dentro la città-stato (la città come stato, lo stato come città), dunque dentro uno spazio fisico-psicologico-sociale; ma non solo: perché oltre queste dimensioni ce n’è un’altra che preme, urge, e non si fa cancellare – la dimensione spirituale. La polis è lo spazio all’interno del quale hanno luogo i rapporti umani – e primi fra tutti, come li aveva già identificati una lunga tradizione della classicità greco-romana, i rapporti di amicizia. (Lo dice uno che sa bene, nella sua vita semi-desertica, quanto sia arduo instaurare questi rapporti: dunque, nulla di mieloso e idillico nella mia pronunzia della parola “amicizia”.)
Non c’è in ultima analisi un conflitto fra politica e amicizia. Le due categorie coesistono, anzi si intersecano, se uno impara a vivere il proprio interesse politico con un certo distacco, ovvero equilibrio fra l’elemento attivo e quello contemplativo; e qui si torna alla dimensione spirituale. (Diverso, probabilmente, è il caso di chi assume un impegno politico a tempo pieno.)
Voglio dire, insomma, che la politica è sempre più importante della politica. Il paradosso è solo apparente: la politica, nella sua base vorrei dire fisiologica, è una rete di rapporti umani rispetto a cui la politica in senso stretto e tecnico rappresenta un’astrazione. Il caso, in fondo, è analogo a quello della poesia: esiste una rete di relazioni psichiche, di intuizioni del mondo, che è la poiesis – ovvero la poietica generale come energia che ognuno di noi possiede entro se stesso. E’ molto difficile mantenerla viva; ma se restiamo completamente privi di essa, avvizziamo. I bambini com’è noto la esprimono in continuazione, nei loro primi anni di vita; poi le strutturazioni sociali, fino a un certo punto necessarie – non credo in ribellismi e anarchismi generici – la costringono nella maggior parte dei casi a nascondersi (poietica clandestina, poietica underground ).
I poeti, per essere tali, debbono operare un’astrazione tecnica rispetto al tessuto vivente e irregolare della poietica. Ognuno di loro sviluppa così, sulle necessarie restrizioni e costrizioni della propria poietica, la sua personale poetica, il proprio piccolo altare portatile e indispensabile. (Sì, è vero, Marinetti per esempio esortava – con una provocazione che ha ancora una sua vena di validità – a sputare ogni giorno sull’altare dell’arte; ma, come in tutte le affermazioni degli avanguardisti intelligenti, cioè dialettici, entrambi gli elementi rimangono dentro la persistente vitalità del mondo: resta la possibilità dello sputo, ma l’altare non è certo distrutto – e Marinetti lo sa bene, e gli va bene che sia così.) Ogni altare è costruito su un sacrificio (resta un cumulo di detriti e rovine, una piccola grotta, sotto di esso); più precisamente: ogni altare costituisce di per se stesso il corpo di un sacrificio … ma stiamo andando lontano – in una direzione che richiede altro discorso, da rinviare per il momento.
L’astrazione tecnica è indispensabile perché sorga un’arte (politica o poetica). L’importante è non dimenticare quello che sta sotto – la grotta sotto l’altare; non dimenticare che la politica è più che la politica, la poesia più che la poesia.
Firenze, 23 maggio 2008
Continua a colpirmi la netta divergenza fra due città vicine: Firenze e Bologna. La prima ha mantenuto la sua tradizione moderna; cioè, l’atmosfera che essenzialmente la definisce nell’oggi è ancora quella tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Le tanto deprecate masse turistiche sono state essenzialmente colonizzate, essendo state confinate ad alcuni ben delimitati percorsi nel centro cittadino; per il resto, Firenze ha essenzialmente resistito (in modo analogo a quello che è accaduto a Venezia). E’ sufficiente questo, per dire che il cuore di Firenze è intatto, che Firenze ha mantenuto la sua anima? Non so se si possa essere così ottimisti; io mi limiterei a dire che il volto di Firenze non è completamente sfigurato.
Bologna d’altro canto – che non ha certo, come Firenze e Venezia, il problema di resistere a una colonizzazione turistica – non ha mantenuto (forse non ha nemmeno mai trovato) una tradizione del moderno; e adesso vive completamente immersa in un caos della contemporaneità. Il suo volto non è tanto sfigurato, quanto irriconoscibile – irriconoscibile ab origine.
 Il mio proposito, qui come altrove, è quello di essere descrittivo: tento di sviluppare una fenomenologia, di fare attenzione al giuoco dei “pieni” e dei “vuoti” – non di aggiudicare fra il bello e il brutto, il male e il bene. La tradizionalità moderna di Firenze è nutrice e ispiratrice – ma essa genera anche un’atmosfera un po’ sonnolenta; e d’altro canto: c’è qualche cosa di aridamente volgare, nell’atmosfera di Bologna – ma c’è anche una vitalità tumultuosa che la assomiglia un poco a New York. Ricordo, anni or sono, un giovanotto bolognese che aveva fatto qualche giravolta per New York e mi spiegava: “In fondo, Bologna è come New York”. Un’esagerazione al limite del ridicolo, certo; e allora ne vidi solo quel limite, e sorrisi tra me e me. Ma poi ci ho riflettuto, e debbo dire che ritiro quel mio sorriso: questo apprezzamento di somiglianza non è completamente assurdo. Ciò si vede soprattutto nei quartieri fra il losco e il bohémien che si diramano dal centro storico e al tempo stesso ne sembrano così lontani.
Il mio proposito, qui come altrove, è quello di essere descrittivo: tento di sviluppare una fenomenologia, di fare attenzione al giuoco dei “pieni” e dei “vuoti” – non di aggiudicare fra il bello e il brutto, il male e il bene. La tradizionalità moderna di Firenze è nutrice e ispiratrice – ma essa genera anche un’atmosfera un po’ sonnolenta; e d’altro canto: c’è qualche cosa di aridamente volgare, nell’atmosfera di Bologna – ma c’è anche una vitalità tumultuosa che la assomiglia un poco a New York. Ricordo, anni or sono, un giovanotto bolognese che aveva fatto qualche giravolta per New York e mi spiegava: “In fondo, Bologna è come New York”. Un’esagerazione al limite del ridicolo, certo; e allora ne vidi solo quel limite, e sorrisi tra me e me. Ma poi ci ho riflettuto, e debbo dire che ritiro quel mio sorriso: questo apprezzamento di somiglianza non è completamente assurdo. Ciò si vede soprattutto nei quartieri fra il losco e il bohémien che si diramano dal centro storico e al tempo stesso ne sembrano così lontani.
Qualche anno or sono, di notte tardi nel quartiere del Pratello, a poca distanza dalla centralissima via Ugo Bassi, mi ero – non perduto, ovviamente, ma sperduto: la notte intorno era insieme sinistra e protettiva, con promesse labirintiche in certo senso tradite dalla prosaicità degli effluvi di spazzatura. Ero molto stanco, mi sentivo in ritardo rispetto agli impegni (preparazione dei bagagli) della ormai non lontana mattina; e quando vidi un tassì vuoto passare all’angolo della strada, mi sembrò un evento perfettamente naturale (come non lo è affatto a Bologna – ma ovviamente il mio cervello stanco si era collegato a New York senza saperlo), e sollevai il braccio destro, nel tipico gesto ripetuto migliaia di volte, lungo i marciapiedi di Manhattan. Non avevo ancora finito di alzare completamente il braccio che lo lasciai ricadere, pensando: ‘Che scemo che sei!’ e immaginandomi l’ironia dell’autista, mentre correva verso il suo appuntamento telefonico, di fronte a quel turista americano stonato. E invece no! Il tassì fece una curva a U con stridìo di freni, mi si fermò davanti di colpo – e in quel momento la stradina diventò una traversa di Broadway… Nessuno mi toglie dalla testa (come diceva mia madre) che quello strano incontro al Pratello fosse una specie di contagio, come dire, anticipato: New York, alla cui volta sarei partito in volo il pomeriggio seguente, aveva già cominciato a farsi sentire, aveva cominciato a invadere il mio spazio bolognese. Così i luoghi della vita cominciano a installarsi in noi ancor prima che vi entriamo fisicamente; e ogni volta finiamo col trovarli là dove eravamo già.
Bologna, 27 maggio 2008
Ripensavo alla peculiarità di Bologna ieri sera, mentre andavo verso la rinnovata sede della cineteca bolognese, il cinema “Lumière”. Dopo quindici/venti minuti dicammino dal centro storico ero già arrivato al cinema – eppure questa brevepasseggiata era stata sufficiente a trasferirmi in un altro piccolo mondo, rispetto a quellodel centro. Sembrava una strada di periferia, anche se chiaramente non sarebbe stato esatto usare un termine diretto come “periferia”, che comporta distanze maggiori e un abitato non più urbano. Suppongo che questo fenomeno para-urbanistico sia statogià studiato dagli esperti, ma io non saprei come definirlo: “periferia centrale”, “centro periferico”? Certo il fenomeno non è limitato a Bologna. Alcuni giorni or sono, a Modena, la tassista che mi stava trasportando dalla stazione ferroviaria aveva respinto con una punta di orgoglio civico ferito la mia definizione di “periferia” per una sorta di mini-cattedrale nel deserto (un “deserto” peraltro fatto di minuscoli villini ben curati, allineati, pettinati): il “Forum Monzani”, che era la destinazione cui mi stavo avvicinando dopo un tragitto in effetti breve.
Ma appunto: la distinzione è qualitativa, non quantitativa – non si tratta di distanze, bensì di atmosfere. In questo senso anche il cinema “Lumière” mi è apparso, al termine della breve passeggiata, come una mini-cattedrale nel deserto. Un “deserto”, peraltro, molto strutturato: nella strada serpentina si alternavano casette ben curate (balconcini, fiori) e spazi con edifici sbadiglianti o bui – e c’era anche un piccolo parco di aspetto un po’ trasandato, forse un po’ equivoco – ma a dire il vero quella sera non c’erano né bambini né adulti sospetti; c’era solo un gruppo di ragazzi e giovanotti che si esercitavano a fare i giocolieri …
 E così mi sono mentalmente ritrovato di nuovo a Manhattan, nelle zone fra il losco e l’artistico del Lower East Side, zone cheospitano fra l’altro le due più importanti cineteche di New York: “Film Forum” e “Anthology Film Archives”. Ecco: lacamminata di avvicinamento alla cineteca di Bologna avevaessenzialmente le stesse caratteristiche della camminata di avvicinamento alle cineteche newyorchesi. E “camminata di avvicinamento” non è un’espressione iperbolica.
E così mi sono mentalmente ritrovato di nuovo a Manhattan, nelle zone fra il losco e l’artistico del Lower East Side, zone cheospitano fra l’altro le due più importanti cineteche di New York: “Film Forum” e “Anthology Film Archives”. Ecco: lacamminata di avvicinamento alla cineteca di Bologna avevaessenzialmente le stesse caratteristiche della camminata di avvicinamento alle cineteche newyorchesi. E “camminata di avvicinamento” non è un’espressione iperbolica.
Nelle analisi sparse in questo Codex Atlanticus tento di sottolineare la pertinenza del contesto materiale per uno spettacolo teatrale o cinematografico: non solo la sala, il tipo di pubblico, ecc., ma anche il contorno urbanistico e sociale, anche l’atmosfera del momento; tutto ciò aiuta a comprendere meglio lo spettacolo – o meglio a comprenderlo in un altro modo: non solo dunque come un oggetto in sé, ma anche come momento di vita contestualizzata, come kairós. Insomma e in sintesi: arrivare allo spettacolo camminando attraverso una zona urbana sospesa tra il sordido e l’istrionico è un ottimo modo per preparasi alla visione dello spettacolo stesso. (Modo modernistico? postmodernistico? No – la mia tesi potrà essere discussa, e certo necessita di ulteriori raffinamenti e approfondimenti, ma almeno ha la coerenza della sua applicabilità generale: propongo che questo tipo di avvicinamento sia sempre esistito, e sempre sia stato pertinente, al di là delle mode estetiche del momento; il vantaggio dell’oggi è che possiamo cominciare a riconoscere esplicitamente tutto ciò – possiamo cominciare a delineare i vari tratti di questa contestualizzazione.) Poi, però, si sono rivelate le differenze …
I dintorni e contorni delle cineteche di Manhattan sono veramente sordidi, o per lo meno oscillanti fra il popolare e il fatiscente: lungo la via che ospita il “Film Forum” si estendono due o tre localini notturni un po’ selvaggi; e quanto agli “Anthology Film Archives” – conosco almeno una signora che si è disaffezionata a quel luogo di sperimentazione filmica da quando ha trovato, al ritorno dello spettacolo, che il baule della sua automobile era stato forzato, con il risultato deprimente che è tipico dei frettolosi furtarelli della miseria: avevano rubato un sacchetto con dentro alcune compere domestiche ... Le salette cinematografiche di quei luoghi, poi, sono proprio modeste: di decorazione interna non si parla nemmeno (il colore dominante è il nerolucido a chiazze biancastre, tipo galleria della metropolitana), molti sedili mostrano l’imbottitura, l’aria condizionata salta dal massimo al minimo, ecc. Che differenza, al “Lumière”! Che è un vero e proprio complesso architettonico, con un banco dei libri, e una grande sala di proiezione dall’aspetto distinto. Però, però – le salette delle cineteche newyorchesi sono sempre piene (a volte, con fila intorno all’isolato), mentre stasera al “Lumière” mi sono ritrovato in una sala semivuota. Può essere stato un caso, s’intende; ma forse non è un caso che in questi giorni i quotidiani locali ospitino dibattiti sulla semideserticità (e anche di questa posso attestare direttamente) dei musei e gallerie d’arte a Bologna.
Io poi mi ero affrettato per essere puntuale (con ingenuità “americana”) pensando che la primizia che si mostrava stasera attirasse molto pubblico: l’ultimo film di Ingmar Bergman, Sarabanda – un film concepito per la TV svedese, e a suo tempo acquistato dalla TV italiana, che però lo ha reso quasi invisibile, relegandolo in angoli notturni della programmazione.
A proposito – ed è un’altra differenza fra l’atmosfera nelle cineteche delle due città: ciò che ho appena notato a proposito del film di Bergman l’abbiamo utilmente appreso dal direttore della Cineteca di Bologna, nella presentazione che ha preceduto il film; ma l’utilità delle informazioni è stata poi soffocata dalla lunghezza della presentazione … Io comprendo e rispetto le differenze antropologiche; solo mi permetto di dire che, dalla prospettiva di New York (la quale non è necessariamente una prospettiva universale, beninteso) c’è qualcosa di lievemente assurdo in una sala semivuota che ascolta con religiosa pazienza per una quarantina di minuti non uno ma ben due oratori, seduti dietro un lungo tavolo con tanto di bottiglie di acqua minerale, come in un congresso scientifico, che discettano sul film che si sta per vedere – o più precisamente: il succitato direttore inquadra brevemente quella produzione, e poi il noto critico cinematografico G. F. discorre a lungo su Bergman, su alcuni diari connessi al film e in vendita nel ridotto, e su vari altri soggetti. E’ vero che in questo modo la cineteca si qualifica come vera e propria cineteca, ma dopo la prima ventina di minuti l’effetto è lievemente allucinatorio: sembra che siamo dentro un film di Chaplin, o dei Fratelli Marx, dove si faccia la parodia di una conferenza…
Ma la differenza generale fra le cineteche di New York (e americane in generale) e quella di Bologna (con le altre italiane) risiede altrove: e precisamente, ha a che fare con l’orrore del doppiaggio. Ci sarebbe tutto un libro da scrivere su questo fenomeno semi-patologico le cui radici, prima che estetiche e psicologiche, devono essere politico-economiche – e chissà se l’establishment cinematografico italiano (ivi compresa la maggior parte dei critici) permetterà mai che questo libro venga scritto.
Qui mi limito a osservare che il doppiaggio – che già risulta bizzarro nelle normali sale dei circuiti commerciali – suona ancor più tale in quel contesto suppostamente “scientifico” di fruizione del film che è la cineteca. Perché ogni film doppiato è perlomeno dimezzato, avendo perduto la sua particolare aura – al di là della comprensione effettiva delle frasi straniere, che è uno pseudoproblema (ci sono i sottotitoli); e comunque il problema è, come si diceva, di aura o atmosfera, non di pedanteria filologica.
Il doppiaggio è l’estremizzazione semi-patologica di processi di defamiliarizzazione o estraniamento; e la sua bizzarria è tale che mi permetto di ribadire il termine usato sopra, il quale può a prima vista apparire eccessivo: orrore. Termine che peraltro qui è inteso in senso ristretto e tecnico, come in: film dell’orrore (e forse avrei dovuto dire horror). Ogni film doppiato, infatti, a qualunque genere esso appartenga (anche la più spumeggiante commedia) finisce con l’assomigliare a un film dell’orrore. Le voci che emergono dallo schermo sono … schermate, come se un vetro opaco si frapponesse fra loro e l’uditore. Uditore, sì; perché il doppiaggio recide la connessione – naturale per chi vede il film nela sua veste originale – fra il processo dell’ascoltare e quello del vedere. I due processi si muovono in direzioni, se non opposte almeno divergenti, e l’unità organica che costituisce lo spettatore si trasforma in divisione potenzialmente conflittuale fra uditore e osservatore.
Insomma, non è esagerato dire che le voci doppiate sono voci ventriloque, voci di zombie: tout se passe comme si (direbbe un critico francese) a un certo punto ogni film doppiato si trasformasse in una storia di persone solo apparentemente vive. La classica difesa del doppiaggio che spesso ascolto dai miei amici (“Ma sono tanto bravi, i nostri doppiatori!”) è sostanzialmente esatta, ma finisce con l’essere una critica ancor più severa di tutto il procedimento. Dopo un po’, infatti, l’osservatore del film doppiato si rende conto che la varietà di quello che vede – le trame le situazioni le conversazioni i personaggi (insomma la varietà dello spettacolo sensorio del mondo, che è la seduzione del cinematografo) – viene indirettamente smentita dalla omogeneità di quello che egli ascolta: le voci sono quasi sempre le stesse (situazione monopolistica dei doppiatori – ma questo è un altro discorso). Si tratta di voci coltivate e abili – ma, appunto: esse invadono con le loro civetterie di timbro, dizione, ritmo (le civetterie che ogni attore deve sviluppare) i timbri dizioni ritmi di altri attori.
Ma, ancora una volta: questa è una modesta descrizione, non una prescrizione o valutazione. Dopotutto, l’orrore nei film dell’orrore è fonte di un peculiare piacere … anche se la, diciamo, pellicola (nel senso di ‘membrana sottile’) dell’orrore sovraimposta a pellicole (nel senso di ‘film’) che appartengano ad altri generi non è fonte di piacere, bensì di dissonanze che lasciano un senso di disagio estetico e psicologico. Ma quella che ho adesso in mente è la già descritta “camminata di avvicinamento” – che più precisamente è la camminata di avvicinamento con cui ci si prepara (in un orizzonte di attesa) a vedere il film, e poi diventa la camminata di allontanamento con cui si lascia lo spettacolo restando tuttavia ancora per qualche tempo nella sua atmosfera. La critica di un film – voglio dire la critica informale del cosiddetto uomo della strada (dunque, la critica decisiva) nasce dal confronto fra queste due camminate.
Forse – e arrivo al punto – forse il modo migliore di avvicinarsi a un film (insisto: avvicinarsi materialmente, camminando in un paesaggio urbano o suburbano) è quello di approssimarsi allo spettacolo attraverso strade un po’ misteriose, non molto illuminate, strade che evochino l’ atmosfera fra il magico e l’equivoco in cui prospera quell’istrionismo senza il quale non si dà spettacolo. Questo tipo di camminata di avvicinamento è la preparazione ideale per un film dell’orrore o film noir – una preparazione che può aiutare lo spettatore – in fieri a rassegnarsi al doppiaggio. Questa non è l’unica preparazione possibile, beninteso: so bene (e ne ho già parlato in una sezione precedente di Codex Atlanticus) che c’è anche un altro modo di avvicinarsi a uno spettacolo teatrale o cinematografico: attraverso la profusione di luci – “le mille luci di New York”, diceva una canzone che ascoltavo da ragazzo – la confusione di veicoli, il tumulto di passanti, che è tipica per esempio di Broadway. E sarebbe interessante vedere che tipo di “poetica” cinematografica sia evocata da quest’ultimo tipo di contesto.
Ma nella camminata di avvicinamento di ieri sera a Bologna io ero già entrato in un’atmosfera da film noir, così che ero meglio preparato all’effetto di disincarnazione lievemente orroristica del doppiaggio. Inoltre, anche se Sarabanda non appartiene tecnicamente al genere del noir, il colore psicologico di questo film è abbastanza cupo. In effetti questa, diciamo così, nerezza risulta essere l’elemento più coerente e forte nel tessuto del film di Bergman.Dove è pur vero che la giovane e acerbamente affascinante figlia di uno dei protagonisti rivendica (e pare che finisca col realizzarla) la sua scelta di vita; ma la maggior concentrazione visiva, dialogica, psicologica del film è puntata su tre persone anziane o invecchianti, con una crudele – ma anche, a tratti, allegramente grottesca – esplorazione del loro decadimento fisico.
Sarabanda offre alcuni scorci di un bel paesaggio boschivoe lacustre, ma quasi tutta l’ “azione” (in realtà, una serie di conversazioni intense) si svolge negli interni di due casette di campagna, con l’eccezione di un dialogo in chiesa. (E’ una chiesetta che ha un aspetto curiosamente cattolico – ricorda certe rustiche chiese altoatesine; ma l’unica altra immagine esplicitamente religiosa del film ci riporta alla gran tradizione luterana: è il primo piano del frontespizio di una edizioneapparentemente ottocentesca di uno dei capolavoridi Kierkegaard, che le maninodose del protagonista sfogliano cautamente; e a proposito: l’unico punto del film in cui il doppiaggio avrebbe svolto una funzione veramente positiva –anche se nel senso di un doppiaggio grafico piuttosto che acustico – sovraimponendo al titolo danese del libro la sua forma usuale in italiano, cioè Aut Aut, è anche, ironicamente, l’unico punto in cui il doppiaggio “tace” e il titolo rimane opaco.)
Ma non è per via di questi interni – o almeno, non è primariamente per questo – che Sarabanda è un film claustrofobico; lo è soprattutto per la malignità che pervade i momenti più riusciti dei suoi dialoghi terribilmente realistici. Eccoci al punto – che ha a che fare con quella che certe tradizioni retoriche chiamano “la fallacia dell’identificazione sentimentale”. In parole povere: Sarabanda è un film che abilmente esprime la sgradevolezza (la familiare sgradevolezza di certe situazioni familiari), e d’altra parte non è un film sgradevole, perché ha un distacco e un controllo espressivo rispetto al suo materiale. Invece il doppiaggio, con il suo stile zombie e disincarnato, involontariamente esprime la malignità dei dialoghi; ma il doppiaggio stesso è malizioso se non proprio maligno, dunque non è in controllo della sua stessa espressione, dunque non ci offre l’aura e la connotazione autentica dei dialoghi (ecco la fallacia).
